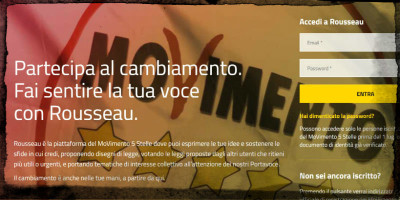22 gennaio – Santa Irene di Roma, la martire che curò le ferite a San Sebastiano martire
"So-do-ma!", "So-do-ma!", "So-do-ma!"
Questa storia
ce la siamo già raccontata: comunque siamo a Firenze intorno al 1515, è un bel pomeriggio di giugno. Ma chi è che urla così? Sono i festeggiamenti per il palio di San Barnaba: i ragazzini stanno chiamando a gran voce il vincitore – che non è il fantino, ma il cavallo – anzi no, il proprietario del cavallo: Giovanni Antonio Bazzi, nato a Vercelli e residente perlopiù a Siena, soprannominato il Sodoma. Lui stesso ha detto alla folla festante di chiamarlo così!
 |
Un San Sebastiano del Mantegna
(1456), con un buffo nodo al perizoma. |
Onde, avendo i fanciulli a gridare come si costuma dietro al palio et alle trombe il nome o cognome del padrone del cavallo che ha vinto, fu dimandato Giovan Antonio che nome si aveva gridare, et avendo egli risposto Soddoma, Soddoma, i fanciulli così gridavano.
Che sfacciato, però. E infatti appena "certi vecchi da bene" se ne accorgono (
"Che porca cosa, che ribalderia è questa, che si gridi per la nostra città così vituperoso nome?") anche i "fanciulli" cambiano atteggiamento. Da festosi diventano violenti e intolleranti. Basta un attimo.
Di maniera, che mancò poco, levandosi il rumore, che non fu dai fanciulli e dalla plebe lapidato il povero Soddoma, et il cavallo e la bertuccia che avea in groppa con esso lui.
Forse la Storia ci piace perché ci fa sentire meno soli. In qualsiasi secolo ci capiti di dare un'occhiata, troviamo sempre persone che amano, odiano, combattono, si stancano, si ammalano: proprio come noi. Tutto quello che succede a noi, è già successo infinite volte e questo a volte ci dà la vertigine, ma più spesso ci è di conforto. Ci è tanto di conforto che conviene diffidare: non è vero, tutte queste persone non erano necessariamente così simili a noi. Leggiamo
un aneddoto di Gian Battista Vasari su un collega che gli stava antipatico, e ci sembra di aver trovato un episodio di omofobia tale quale potremmo leggerlo domani sul giornale ("artista gay inseguito e malmenato"). Non solo, ma ci sembra anche di aver messo a fuoco il prototipo di artista queer del Cinquecento: il Sodoma è una pazza.
 |
San Sebastiano in boxer attillati
(Antonello Da Messina) |
Può anche darsi che il soprannome derivi da un intercalare piemontese, ("su, 'nduma!", "su andiamo": persino
il dizionario biografico Treccani riporta questa etimologia un po' tirata per i capelli), però lui preferiva davvero firmarsi così, e non era la più piccola delle sue stravaganze. Spendeva come un matto, si circondava di ragazzini che gli rubavano in casa, e aveva una specie di fetish per i piccoli animali (“tassi, scoiattoli, bertucce, gatti mammoni, asini nani, cavalli barbari da correre palii, cavallini piccoli dell’Elba, ghiandaie, galline nane, tortole indiane”, più un corvo canterino che gli faceva da segreteria telefonica). Il Sodoma è irriverente, non ha rispetto per nessuno. I benedettini di Monte Oliveto lo chiamano mattaccio, lui si vendica infilando un gruppo di donne nude nelle storie di San Benedetto, poi pur di farsi pagare le riveste. Certo, la Treccani nega tutto, lo definisce "irreprensibile", ma noi la sappiamo più lunga, noi e la nostra volontà di sapere, noi abbiamo il gay radar che sfida i secoli. Tanto più che ha dipinto un San Sebastiano abbastanza famoso. E nel Cinquecento, dipingere un bel San Sebastiano nudo e sagittato doveva equivalere più o meno a un coming out, no? Le frecce naturalmente alludono alla penetrazione, come nelle raffigurazioni postmoderne del secondo Novecento; nell'espressione vagamente estatica non ci resta che riconosce un orgasmo, come
Lacan (e Odifreddi) lo individuano nel marmo dell'Estasi di Santa Teresa. Tutto chiarissimo; oppure invece no.
Il Sebastiano del Sodoma guarda in alto, verso un angelo che sta per deporre la sua testa l'agognata corona del martirio. È un errore curioso che molti critici e storici dell'arte non notano, appunto perché sono critici e storici dell'arte e non sono obbligati a sapere che Sebastiano non fu martirizzato con le frecce. Ovvero, la versione ufficiale (che nel Cinquecento era ancora quella di Iacopo da Varazze) stabilisce che Sebastiano fu attaccato a una colonna e sagittato "come un porcospino": è senz'altro l'episodio più famoso della sua vita... ma non è il martirio. La corona deve ancora aspettare.
Alle frecce, infatti, Sebastiano sopravvive grazie alle cure di Santa Irene di Roma e della sua domestica, Lucina. Queste due pie donne, venute a seppellirlo, si accorgono che respira ancora: nottetempo lo trasportano nella ricca casa di Irene (patrizia romana) e gli estraggono le frecce a una a una: lunga fatica clandestina che a noi lettori moderni sembra già accanimento terapeutico. Perché prolungare la vita a chi si è votato al martirio? E infatti appena guarito, Sebastiano corre a riconsegnarsi all'imperatore che lo ri-condanna, stavolta a morire flagellato: ed è la volta buona. Ad altri santi servono quattro o cinque supplizi prima di ottenere corona e paradiso.
 |
| Luigi Miradori (XVII sec.): Sebastiano curato dalla vedova Irene. |
Le torture ridondanti dei santi della Leggenda Aurea ci sembrano un controsenso morboso: perché donare la propria vita a Dio deve essere così complesso e doloroso? Perché San Giorgio deve essere battuto, sospeso per i piedi, lacerato, tagliato in due con una ruota, risuscitato e poi di nuovo decapitato? In certi casi Iacopo si stava semplicemente sforzando di armonizzare storie divergenti in quella che oggi chiamiamo
continuity: c'è chi dice che Sebastiano morì per le frecce, altri dicono che morì per le frustate, Iacopo non vuole rinunciare a nessuna storia. In controluce comincia ad apparire anche l'ambiguità del desiderio di morte del martire, che la Chiesa è molto attenta a non confondere con la pulsione suicida: è lecito agognare alla corona del martirio, ma non è concesso accelerarla; i feriti comunque si curano, come Sant'Irene curò Sebastiano.
 |
Ancora il Mantegna: una freccia è orientata
diversamente dalle altre, ed è quella
che più lo fa sanguinare. |
Il fatto che la stragrande maggioranza delle raffigurazioni di Sebastiano non si concentri sul martirio, ma su una tortura da cui Sebastiano guarì, è un dettaglio cruciale per comprendere la fortuna medievale del santo. Molto prima di diventare (ufficiosamente) il santo preferito dei sodomiti, Sebastiano era venerato da appestati e lebbrosi. L'icona tipica di Sebastiano è un'immagine di sofferenza e di violenza inaudita, ma non è un'immagine di martirio. È senz'altro una sofferenza da offrire a Dio: molto prima che lo dipingesse il Sodoma, in tanti quadri Sebastiano già guardava in alto. Ma è una sofferenza che può ancora essere curata. L'icona di Sebastiano è un'immagine di speranza. Lui fu curato da Sant'Irene: tu puoi essere curato da lui. Fino a tutto il Quattrocento, almeno, nelle pale e nei polittici italiani questo messaggio è abbastanza chiaro: Sebastiano, il soldato favorito dell'imperatore Diocleziano, è ritratto di solito in scala 1:1 con espedienti prospettici che lo rendono particolarmente
vicino allo spettatore: le frecce che gli lacerano la carne potremmo toglierle noi. Forse le abbiamo scoccate noi. Forse anche lui soffre per i nostri peccati: le sue piaghe sono anche le nostre ("Le tue frecce, Sebastiano, sono conficcate in me", si legge sotto al Sebastiano più sensuale del Perugino, al Louvre). E però già nel corso del Quattrocento il messaggio è sempre meno limpido, più intorbidito da tensioni contrastanti. Sebastiano non è più il rude soldato barbuto del medioevo, ma un bel modello efebico o muscoloso, a seconda dei gusti del pittore (o del committente). Già da fine Trecento Sebastiano ha perso il monopolio della peste e delle epidemie: molti fedeli gli preferiscono San Rocco. Per sopravvivere nelle Sacre Conversazioni deve trovare un'altra specialità, e l'Umanesimo gliene fornisce una inaspettata: i miti greco-romani tornano di moda e questo santo soldato, a volte ritratto con una freccia in mano,
viene rapidamente sovrapposto all'immagine di Apollo arciere.
 |
Il Savonarola di Fra Bartolomeo. Il suo San Sebastiano
invece è talmente peccaminoso che hanno tolto
anche le foto da Internet, giuro, non riesco a trovarne.
Consolatevi col profilo di fra Girolamo. |
Anche Apollo era associato alle epidemie: la freccia era per gli antichi il simbolo di qualsiasi azione a distanza, e tale sarebbe rimasta più o meno fino alla diffusione delle armi da fuoco. Anche quando smetterà di essere decifrata come simbolo di un contagio epidemico, la freccia resta sino ai giorni nostri il simbolo dell'altra azione a distanza che incuriosiva poeti artisti e filosofi sin dall'antichità: l'innamoramento. Apollo è il dio più bello: e tale diventa Sebastiano nel nuovo pantheon greco-romano-cattolico. Tale lo concepisce un amico e collega di Sodoma, il fra Bartolomeo autore del più celebre ritratto dell'arcigno Savonarola, che quasi per sfida decide di dipingerne uno così bello che i frati del convento si sentono "portati al peccato" e decidono di disfarsene. Da questo aneddoto, e dall'altro di Sodoma che dipinge donne nude dove i benedettini non le volevano (malgrado
la leggenda le prevedesse), capiamo che committenti e pittori non parlano più la stessa lingua; i primi vogliono ancora immagini devozionali, i secondi si rassegnano a fornirle ma sono pur sempre artisti, hanno vite incasinate, interessi non sempre leciti e vivono dinamiche competitive: non è che perché ha dipinto un Sebastiano bellissimo, dobbiamo dedurre che fra Bartolomeo lo concupisse. A quel punto del Cinquecento, dipingere un Sebastiano era una sfida coi colleghi e con sé stessi: significava dipingere un ragazzo nudo e bellissimo, così come
dipingere un Bartolomeo significava dipingere uno scorticato. Più bello era, più riuscito risultava – anche oltre le aspettative e le necessità di chi l'affresco lo pagava.

I pittori del Rinascimento sono anche anatomisti: la figura di Sebastiano consente loro di indagare su aspetti che altri soggetti non consentivano. È l'unico santo di cui è consentito abbozzare sulla tela il pene, anche se coperto (e a volte la copertura ha una consistenza fallica: vedi quel maliziosetto del Perugino). Un pene lo abbozza persino l'austero Piero della Francesca, nel polittico della Madonna della Consolazione; per notarlo dobbiamo confrontarlo con il Cristo dello stesso polittico, a cui il pittore non osa aggiungerlo. In più di un caso i pittori, non potendo aggiungerlo, vi alludono puntando una freccia proprio in quella direzione (ed è la ferita che produce più sangue). Il messaggio è ambiguo: la freccia è il peccato, o la punizione che Dio ci riserva per esso, o la sofferenza di amore che il soggetto (passivo) deve sopportare, oppure va' a sapere, spesso i pittori non sanno perché decidono di dipingere una cosa invece di un'altra. E dobbiamo presumere che anche i committenti non fossero tutti bacchettoni ipocriti come i frati o i benedettini: che ci fosse anche chi desiderava Sebastiani bellissimi e non troppo trafitti; non si spiega altrimenti la sopravvivenza del modello anche dopo la Controriforma, quando gli alti prelati già avevano messo nero su bianco che Sebastiano andava dipinto come nel medioevo, barbuto e magari vestito. Lo stesso Michelangelo nel Giudizio Universale non rinuncia a raffigurare un ragazzone aitante, che brandisce le frecce e sembra dire ai dannati sottostanti: io il Paradiso me lo sono sudato. Anche l'iconografia di Sant'Irene che cura il soldato ferito continua ad avere successo, e anche in questo caso Irene non è sempre una vedova in età avanzata.
All'Irene della Leggenda Aurea capita poi di scoprire in sogno che il cadavere di Sebastiano è stato gettato nella Cloaca Massima. Lo seppellisce lì nei pressi, in quelle che poi saranno chiamate Catacombe di Sebastiano.