Pages - Menu
▼
Collaborazioni
▼
martedì 30 luglio 2019
lunedì 29 luglio 2019
Gesù e la colf
 |
| Se abbiamo bisogno di qualcosa ti chiamiamo noi, grazie |
[2012]. Comincia tutto nel vangelo di Luca, con una episodio che sta in cinque versetti (10,38-42): Gesù predica in casa di due sorelle, Marta e Maria. Quest'ultima resta seduta ai suoi piedi ad ascoltarlo, mentre Marta attende ai lavori domestici, finché non sbotta: ehi, Gesù, lo vedi come sono messa? di' a mia sorella che mi aiuti.
Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta».Luca, lo abbiamo visto, è l'evangelista liberal: ha un debole per i poveri, gli extracomunitari, le donne. Forse, come ogni liberal si rispetti, a casa aveva pure dei domestici, che trattava con molta gentilezza, versando i contributi e usando la frusta solo in caso di estrema necessità. Chissà. In ogni caso ogni progressismo ha un limite, e quello di Luca riguarda i lavori domestici: tutti possono seguire Gesù, tutti possono entrare nel Regno dei Cieli, però gli sguatteri in seconda fila, grazie. Non è che il loro lavoro non sia utile, anzi. Però qualcun altro si è scelto la parte migliore: un modo educato per dire che a voi è rimasta la peggiore. Luca non immaginava forse che la religione che stava contribuendo a fondare avrebbe attecchito nelle metropoli proprio presso quel ceto sradicato senza tradizioni e senza prospettive, la servitù. Gli schiavi che venivano comprati e venduti nei porti del mediterraneo si mescolavano tra loro, cercavano un'identità comune e un riscatto almeno ideale: lo trovarono in una fede religiosa che implicava l'uguaglianza di schiavi e padroni davanti a Dio, ma a quel punto l'episodio di Marta cominciò a creare difficoltà. Per ogni vergine che si consacrava alla vita contemplativa, all'estasi e alle rivelazioni mistiche, dovevano esserci una o più Marte che continuassero a rigovernare le case. Tra la sorella incantata ai piedi del Salvatore, e quella indefessa e brontolona che continua ad andare su e giù tra cucina e lavatoio, lo zoccolo duro dei fedeli ha sempre istintivamente tifato per la seconda. Anche personaggi insospettabili, come Agostino e persino Teresa d'Avila, hanno lasciato scritto che la "parte" di Marta è fondamentale, irrinunciabile, complementare a quella di Maria, eccetera. Però alla fine se torniamo alla lettera del vangelo, vediamo che il Gesù di Luca la mette giù molto più semplice e brutale: Marta è una che si agita per molte cose inutili. Nel vangelo c'è scritto così, se non vi va scrivete un altro vangelo.
 |
| Sì, vabbe', miracolo, ma che puzza. |
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo».Guardandosi bene dal pretendere un miracolo qui-e-ora, Marta pronuncia la professione di fede necessaria a ottenerlo. È l'ultimo dei sette "segni" che nel vangelo di Giovanni attestano la divinità di Gesù; è anche quello che ne causa il martirio: siamo insomma al centro di tutta la buona novella, e al centro c'è una sguattera. Dai tempi di Luca sono passati venti o trent'anni, ma ormai i servi hanno preso il sopravvento, e si stanno forse plasmando un Salvatore a loro uso e consumo: più gentile di quello dei sinottici, più umano, un amico che piange i fratelli morti, e che si fa intenerire dai discorsi di una colf. Perché Marta dentro è rimasta una colf, come si vede bene qualche versetto più giù, dove ribadisce la sua essenza di donna pratica nell'esatto momento del prodigio. Qui, senza apertamente dubitare della divinità del Cristo, si permette di far notare che se si scopre la tomba dopo quattro giorni probabilmente ne uscirà un cattivo odore.
Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni».Dopo il miracolo Gesù torna nel capitolo 12 a trovare la famiglia e a farsi ungere i piedi da Maria (Marta serve in tavola). Lazzaro a quel punto è una celebrità, vengono da lontano per vederlo; però di lui e delle sue sorelle nessuno parla più. Successivamente le leggende li localizzano qui e là per tutto il Mediterraneo: Lazzaro sarebbe diventato il vescovo di Kittim, Cipro, oppure di Marsiglia, Francia. Quest'ultima ipotesi è compatibile con lo sbarco di Marta e delle tre Marie tra Provenza e Camargue, dove avrebbero compiuto varie imprese. A Marta ovviamente è assegnata una delle più pedestri: sconfiggere il Tarasque, uno di quei mostri medievali dal fiato mefitico che rendevano malsani gli acquitrini. Alla fine si trattava di fare pulizie, come al solito. Marta è la protettrice delle casalinghe, delle collaboratrici domestiche, degli albergatori, dei ristoratori, dei cuochi, delle cognate, di tutte le donne e gli uomini che si lamentano perché non li stai aiutando e allora tu ti alzi e loro ti dicono che tanto ormai è troppo tardi e hanno già finito e dopo un'ora sono ancora lì che passano qualcosa sul pavimento e brontolano ma non puoi più alzarti perché contamineresti il pavimento, e poi non c'è proprio niente da fare, è la parte peggiore, se la sono scelta.
sabato 27 luglio 2019
Dormire come sette
27 luglio - Sette dormienti di Efeso
[2014] In una grotta, dalle parti di Efeso (Lidia, oggi Turchia sudoccidentale), forse riposano ancora i Sette Dormienti. Si chiusero nella grotta ai tempi di Decio imperatore, per sfuggire alle sue violente persecuzioni. Si coricarono, e il mattino dopo mandarono uno di loro a comprare il pane. Al tizio la città sembrò subito un po' cambiata. In ogni foro, grandi edifici sormontati da croci. La gente non voleva il suo denaro, e sì che era argento buono, coniato sotto Decio imperatore. Ci misero un po', i Sette, a capire che avevano dormito duecento anni. La loro religione, già proibita, ora era obbligatoria. Inoltre fra Decio e Teodosio imperatore vi erano state almeno tre riforme monetarie, quindi forse era difficile capire cosa si potesse comprare ora col denaro che si erano portati nella grotta, al di là del valore intrinseco. Racconta la leggenda che i Sette morirono quello stesso giorno, dopo aver ringraziato il Signore per averli tenuti in stand-by tutto quel tempo; il che non ha molto senso da un punto di vista narrativo, ma è una pezza necessaria se sei un agiografo e vuoi conservare il loro status di santi - in alcuni calendari vengono chiamati anche martiri, il che è abbastanza incongruo.
È facile immaginare che il mito esistesse già prima dell'avvento del cristianesimo (che a Efeso arrivò prestissimo, già ai tempi di Paolo). Da un punto di vista cristiano, non ha molto senso sottrarsi al martirio durante una persecuzione - anzi in certi periodi era considerato un vero e proprio tradimento: il vero cristiano dimostrava la sua fede andando incontro ai supplizi, non imboscandosi in una grotta. D'altro canto, la leggenda era troppo bella per rinunciarvi. È in sostanza il primo viaggio nel tempo della storia della narrativa. Non si può però venerare un dormiente: finché dorme non è in cielo. Deve dunque essere morto, possibilmente subito dopo il risveglio miracoloso.
Che la leggenda sia antica, e famosa, lo dimostra anche la sua presenza in un testo d'eccezione, il Corano. Nella Sura della Caverna, Maometto afferma che i giovani dormirono 300 anni "più nove" (309 anni lunari = 300 anni solari?). Poi si svegliarono freschi e decisero di mandare in città qualcuno ad acquistare il cibo, con gentilezza; questa parola ("comportarsi con gentilezza") pare sia il centro esatto di tutto il Corano. In città vengono scoperti e onorati. Ma quale città? Efeso o Ahl al-Kahf, in Giordania? O a Chenini, in Tunisia, dove si ritiene che dormano ancora senza aver mai smesso di crescere, e quindi non potranno che risvegliarsi giganti? Maometto non lo dice. Non chiarisce nemmeno quanti fossero i giovani, ma di una cosa è sicuro: con loro c'era un cane. Quel cane che ancora è udito dai viandanti nei pressi di Azeffoun, Algeria.
Kolosimeggiamo un po’, dai. Mettiamo che Osiride, Horus, Seth, Nefti e tutta la combriccola siano i rappresentanti di una civiltà avanzata che si ritrova a regnare sull’Egitto dell’età del bronzo. A un certo punto scoppia un litigio, Seth ferisce Osiride, ma la tecnologia per guarire Osiride non è più disponibile. Si può soltanto ibernare e aspettare. Con gli anni, tutti i suoi colleghi lo seguono, in un sito perfettamente occultato. Gli egiziani continuano a governarsi da soli, facendo tesoro di alcune innovazioni tecniche portate da Osiride, e dimenticandone altre. Anche la pratica dell’imbalsamazione dei faraoni potrebbe essere nata per scimmiottare le tecniche criogeniche dell’ing. Anubi. I sette dormienti sarebbero ancora nascosti da qualche parte, in attesa di qualcosa che non sappiamo. “Non discutere di ciò, eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito”.
Come ormai saprete siamo nei giorni della Canicola, la levata eliaca della stella Sirio (il Cane); tre giorni fa festeggiavamo San Cristoforo, che nelle prime raffigurazioni aveva la testa da cane come Anubi, e faceva un mestiere simile (il traghettatore). Il 29 luglio invece è la festa di San Lazzaro, l’unico uomo a essere stato risorto da Gesù prima della fine dei tempi: un’eccezione incongrua, proprio come quella dei sette dormienti.
Il mito del sonno sospeso è comune a culture diverse e lontanissime: vi è un dormiente nel Talmud, uno in una leggenda cinese del decimo secolo, uno giapponese un po’ più antico, altri simili nei folklori europei – fino alla Bella Addormentata (ma anche i Sette Nani vivono da qualche parte in una caverna fuori dal tempo). Nell’Ottocento Washington Irving si inventa Rip Van Winkle, un contadino fuori New York che dopo un diverbio con la moglie esce di casa e ritorna vent’anni dopo con una barba lunga. Racconta di essere stato accolto in una caverna da dei tizi strani che gli hanno fatto bere qualcosa di molto forte (i superstiti della spedizione di Hudson, abbandonati dopo l’ammutinamento del 1611?) Quando si proclama fedele suddito di Re Giorgio, i locali restano sbigottiti: Rip si è dormito tutta la rivoluzione. Un po’ lo invidiano.
Nel 1961 Rod Sterling scrive per la seconda stagione della serie tv Twilight Zone (Ai confini della realtà) un episodio in cui quattro rapinatori, dopo una fortunata visita a Fort Knox, si nascondono in una caverna nel deserto dove hanno preparato tutto l’occorrente per ibernarsi. Quando si sveglieranno, nel 2061, chi si ricorderà di loro e della loro refurtiva in lingotti d’oro? Uno dei quattro è ovviamente lo scienziato matto dell’occasione, incurante del consiglio del profeta: non dire mai di nessuna cosa: “Sicuramente domani farò questo…” senza dire “…se Allah vuole” . Gli altri tre sono un po’ perplessi, ma si chiudono comunque nelle teche criogeniche.
Si svegliano poco dopo. Quanto tempo è passato? Impossibile capirlo. Però sono rimasti in tre – la quarta teca è stata danneggiata da una roccia. Dentro c’è uno scheletro completamente bianco. Quindi sono nel 2061? Risalgono sulle vetture, ma scoppia un diverbio. Un altro rapinatore ci lascia le penne. Ora le vetture sono inservibili e i rapinatori sono rimasti in due. Nel deserto. Con due sacchi di lingotti d’oro.
C’è solo una strada. Dov’è tutta la gente? In cielo non un aeroplano. Siamo davvero nel 2061? Dove sono le macchine volanti? Dopo un po’ uno dei due ha sete. La sua borraccia è finita. Hai sete? Io ho ancora un po’ d’acqua. Ma ti costa un lingotto d’oro.
I superstiti vengono alle mani. Forse sono tutto quel che resta dell’umanità; in ogni caso uno ammazza l’altro e rimane solo nel deserto, senz’acqua e con due sacchi di lingotti d’oro. Prosegue per l’unica strada. Prima di soccombere, vede finalmente arrivare un veicolo futuristico (un avanzo del set del Pianeta proibito, girato cinque anni prima). Ne scende un tizio vestito in modo strano. Acqua, voglio acqua, dice l’assassino. Ve la pago. E brandisce un lingotto. Va bene, dice il tizio, ma l’assassino muore subito dopo.
Nel veicolo c’è anche una signora. Che voleva, caro? Acqua. Pensa, in cambio voleva darmi questo. Questo affare? E che roba è? Un lingotto d’oro. Una volta era molto prezioso, lo usavano per scambiare le cose. Lo butta via e riparte sul veicolo.
In Galles, Germania, Scandinavia, Ungheria e Boemia, “sette-dormiente” significa dormiglione. In Siria ti augurano di dormire “come quelli di Efeso”. Buona notte anche voi, a Dio piacendo.
 |
| Questa è una versione turca. |
[2014] In una grotta, dalle parti di Efeso (Lidia, oggi Turchia sudoccidentale), forse riposano ancora i Sette Dormienti. Si chiusero nella grotta ai tempi di Decio imperatore, per sfuggire alle sue violente persecuzioni. Si coricarono, e il mattino dopo mandarono uno di loro a comprare il pane. Al tizio la città sembrò subito un po' cambiata. In ogni foro, grandi edifici sormontati da croci. La gente non voleva il suo denaro, e sì che era argento buono, coniato sotto Decio imperatore. Ci misero un po', i Sette, a capire che avevano dormito duecento anni. La loro religione, già proibita, ora era obbligatoria. Inoltre fra Decio e Teodosio imperatore vi erano state almeno tre riforme monetarie, quindi forse era difficile capire cosa si potesse comprare ora col denaro che si erano portati nella grotta, al di là del valore intrinseco. Racconta la leggenda che i Sette morirono quello stesso giorno, dopo aver ringraziato il Signore per averli tenuti in stand-by tutto quel tempo; il che non ha molto senso da un punto di vista narrativo, ma è una pezza necessaria se sei un agiografo e vuoi conservare il loro status di santi - in alcuni calendari vengono chiamati anche martiri, il che è abbastanza incongruo.
È facile immaginare che il mito esistesse già prima dell'avvento del cristianesimo (che a Efeso arrivò prestissimo, già ai tempi di Paolo). Da un punto di vista cristiano, non ha molto senso sottrarsi al martirio durante una persecuzione - anzi in certi periodi era considerato un vero e proprio tradimento: il vero cristiano dimostrava la sua fede andando incontro ai supplizi, non imboscandosi in una grotta. D'altro canto, la leggenda era troppo bella per rinunciarvi. È in sostanza il primo viaggio nel tempo della storia della narrativa. Non si può però venerare un dormiente: finché dorme non è in cielo. Deve dunque essere morto, possibilmente subito dopo il risveglio miracoloso.
Che la leggenda sia antica, e famosa, lo dimostra anche la sua presenza in un testo d'eccezione, il Corano. Nella Sura della Caverna, Maometto afferma che i giovani dormirono 300 anni "più nove" (309 anni lunari = 300 anni solari?). Poi si svegliarono freschi e decisero di mandare in città qualcuno ad acquistare il cibo, con gentilezza; questa parola ("comportarsi con gentilezza") pare sia il centro esatto di tutto il Corano. In città vengono scoperti e onorati. Ma quale città? Efeso o Ahl al-Kahf, in Giordania? O a Chenini, in Tunisia, dove si ritiene che dormano ancora senza aver mai smesso di crescere, e quindi non potranno che risvegliarsi giganti? Maometto non lo dice. Non chiarisce nemmeno quanti fossero i giovani, ma di una cosa è sicuro: con loro c'era un cane. Quel cane che ancora è udito dai viandanti nei pressi di Azeffoun, Algeria.
Diranno: “Erano tre, e il quarto era il cane”. Diranno, congetturando sull'ignoto: “Cinque, sesto il cane” e diranno: “Sette, e l'ottavo era il cane”. Di': “Il mio Signore meglio conosce il loro numero. Ben pochi lo conoscono”. Non discutere di ciò, eccetto per quanto è palese e non chiedere a nessuno un parere in proposito. Non dire mai di nessuna cosa: “Sicuramente domani farò questo...” senza dire “...se Allah vuole” (Sura XVIII,22-24)Il cane è del tutto assente nella versione cristiana. Secondo il Corano anche lui dormì per tutto il tempo, assolvendo comunque la funzione di guardiano: stava sulla soglia e dissuadeva chiunque passasse di lì a curiosare nella caverna. Il cane non è un animale molto apprezzato in ambito islamico, anche se Maometto non sembra considerarlo impuro (si raccomanda però che siano lavate molto bene le stoviglie e i vestiti in cui ha ficcato il muso). Impossibile non pensare al dio egiziano Anubi, testa di cane, guardiano del mondo dei morti, e al suo padrone Osiride, anche lui congelato in uno stato di sonno o animazione sospesa, fino alla vittoria finale del figlio Horus sul suo assassino, il fratello Seth. Anubi per l'occasione dovrebbe anche avere inventato l'imbalsamazione - sempre che non fosse un procedimento criogenico per ibernarlo in attesa dell'arrivo di qualcosa che poi non si è fatto vivo, magari rinforzi da Sirio su dischi volanti - da bambino devo aver letto qualcosa di Kolosimo in merito. Da bambino mi faceva un po' paura Kolosimo, pensavo fosse russo o almeno americano. Poi ho scoperto che è nato a Modena.
| Tuttora mi domando: non è terrestre? |
Come ormai saprete siamo nei giorni della Canicola, la levata eliaca della stella Sirio (il Cane); tre giorni fa festeggiavamo San Cristoforo, che nelle prime raffigurazioni aveva la testa da cane come Anubi, e faceva un mestiere simile (il traghettatore). Il 29 luglio invece è la festa di San Lazzaro, l’unico uomo a essere stato risorto da Gesù prima della fine dei tempi: un’eccezione incongrua, proprio come quella dei sette dormienti.
Il mito del sonno sospeso è comune a culture diverse e lontanissime: vi è un dormiente nel Talmud, uno in una leggenda cinese del decimo secolo, uno giapponese un po’ più antico, altri simili nei folklori europei – fino alla Bella Addormentata (ma anche i Sette Nani vivono da qualche parte in una caverna fuori dal tempo). Nell’Ottocento Washington Irving si inventa Rip Van Winkle, un contadino fuori New York che dopo un diverbio con la moglie esce di casa e ritorna vent’anni dopo con una barba lunga. Racconta di essere stato accolto in una caverna da dei tizi strani che gli hanno fatto bere qualcosa di molto forte (i superstiti della spedizione di Hudson, abbandonati dopo l’ammutinamento del 1611?) Quando si proclama fedele suddito di Re Giorgio, i locali restano sbigottiti: Rip si è dormito tutta la rivoluzione. Un po’ lo invidiano.
Nel 1961 Rod Sterling scrive per la seconda stagione della serie tv Twilight Zone (Ai confini della realtà) un episodio in cui quattro rapinatori, dopo una fortunata visita a Fort Knox, si nascondono in una caverna nel deserto dove hanno preparato tutto l’occorrente per ibernarsi. Quando si sveglieranno, nel 2061, chi si ricorderà di loro e della loro refurtiva in lingotti d’oro? Uno dei quattro è ovviamente lo scienziato matto dell’occasione, incurante del consiglio del profeta: non dire mai di nessuna cosa: “Sicuramente domani farò questo…” senza dire “…se Allah vuole” . Gli altri tre sono un po’ perplessi, ma si chiudono comunque nelle teche criogeniche.
Si svegliano poco dopo. Quanto tempo è passato? Impossibile capirlo. Però sono rimasti in tre – la quarta teca è stata danneggiata da una roccia. Dentro c’è uno scheletro completamente bianco. Quindi sono nel 2061? Risalgono sulle vetture, ma scoppia un diverbio. Un altro rapinatore ci lascia le penne. Ora le vetture sono inservibili e i rapinatori sono rimasti in due. Nel deserto. Con due sacchi di lingotti d’oro.
C’è solo una strada. Dov’è tutta la gente? In cielo non un aeroplano. Siamo davvero nel 2061? Dove sono le macchine volanti? Dopo un po’ uno dei due ha sete. La sua borraccia è finita. Hai sete? Io ho ancora un po’ d’acqua. Ma ti costa un lingotto d’oro.
I superstiti vengono alle mani. Forse sono tutto quel che resta dell’umanità; in ogni caso uno ammazza l’altro e rimane solo nel deserto, senz’acqua e con due sacchi di lingotti d’oro. Prosegue per l’unica strada. Prima di soccombere, vede finalmente arrivare un veicolo futuristico (un avanzo del set del Pianeta proibito, girato cinque anni prima). Ne scende un tizio vestito in modo strano. Acqua, voglio acqua, dice l’assassino. Ve la pago. E brandisce un lingotto. Va bene, dice il tizio, ma l’assassino muore subito dopo.
Nel veicolo c’è anche una signora. Che voleva, caro? Acqua. Pensa, in cambio voleva darmi questo. Questo affare? E che roba è? Un lingotto d’oro. Una volta era molto prezioso, lo usavano per scambiare le cose. Lo butta via e riparte sul veicolo.
In Galles, Germania, Scandinavia, Ungheria e Boemia, “sette-dormiente” significa dormiglione. In Siria ti augurano di dormire “come quelli di Efeso”. Buona notte anche voi, a Dio piacendo.
venerdì 26 luglio 2019
Il santo che tolsero da tutti i portachiavi
25 luglio - San Cristoforo, cinocefalo, ex patrono degli automobilisti
[2012]"Wof".
"Ciao Cristoforo, qual buon vento! Erano secoli che..."
"Taglia corto. Voglio vedere il capo".
"Il... il capo non riceve, mi dispiace".
"Cosa vuol dire che non riceve. Non ha senso. Io gli devo parlare. Adesso".
"Adesso no, Cristoforo, adesso è in... in riunione".
"Ecco. Parliamo di queste riunioni. Cosa sta succedendo là sotto, me lo vuoi spiegare? Cosa stanno combinando?"
"Ma niente... rimettono a posto il calendario, cose che capitano, d'altronde ogni tot secoli una riforma è necessaria, devi pensare che arriva gente nuova in continuazione, e così..."
"E io che c'entro? Forse che ho fatto qualcosa che non va?"
"Ma no Cristoforo, non c'è niente che non vada, però..."
"È vero che mi tolgono il patronato degli automobilisti? Perché? Forse che non li ho protetti?"
"Hai fatto quel che hai potuto, ma..."
"E poi se li tolgono a me a chi li danno, scusa".
"A Sant'Antonio, pare".
"Antonio? L'eremita?"
"Noo. Quello nuovo, il francescano... Antonio di Padova".
"Il ragazzino? E che ha fatto, scusa, che c'entra lui cogli automobilisti".
"L'hanno visto col Bambino in braccio, miracolo attestato in un processo di canonizzazione".
"Col Bambino in braccio? E io allora? Non ce l'ho un affresco col bimbo in spalla in tutte le cattedrali d'Europa?"
"Cristoforo, eddai..."
"In braccio. Quel francescano smagrito. Ma vuoi mettere. Gesù si tiene sulle spalle. Seduto comodo, in posizione frontale, come un automobilista, appunto. Sennò vabbe', capirai, il bimbo in braccio... allora diamolo pure alla Madonna, il patronato degli automobilisti. Ma chi è questo Antonio. È appena arrivato e già fa le scarpe agli anziani".
"È qui da sette secoli, ormai..."
"Appunto. Una matricola. Io lo sai che sono qui da quando hanno messo in piedi la baracca".
"Forse anche da prima".
"Esatto".
"È un po' questo il problema, Cris. Tu sei veramente un po' antico".
"Arf! Che male c'è?"
"Basta vedere gli affreschi più vecchi, il bambino sembra minuscolo sulle tue spalle".
"Sono un gigante, e allora? Cosa c'è di male?"
"C'è che i giganti non esistono, Cristoforo".
"Che ne sai tu. Una volta, magari..."
"Una volta, una volta. Adesso queste cose si sanno. C'è la paleontologia, l'archeologia. I giganti non sono mai esistiti".
"Magari ero un Neanderthal".
"Eddai Cristoforo, non fare il furbo. È saltata fuori questa cosa imbarazzante della cinocefalia".
"Wof, di che parli?"
"Nelle raffigurazioni più antiche avevi la testa di un cane, Cris"
"Embè?"
"Senti, non è niente di personale. Non è che ti cacceranno proprio... ti toglieranno dalla prima fila del calendario, questo sì".
"Bau! Cosa?"
 "Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi..."
"Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi..."
"Io mi sono difeso bene, non puoi dire di no".
"Non sto dicendo questo. Però cerca di metterti nei panni del capo. È un ruolo importante. Non possiamo metterci uno che forse all'inizio aveva la testa di cane. Serve un tizio che abbia dei riferimenti storici, uno di cui si possa dimostrare l'esistenza. Mentre tu..."
"Io cosa? Cosa c'è che non va con me?"
"Tu sei una leggenda, Cristoforo, dai".
"Ma siamo tutti leggende, qui..."
"Tu più di altri. Sei un mostro che guada il fiume col bambino sulle spalle. Magari eri una figura mitologica legata a qualche guado di fiume, o il guardiano di un ponte. Sempre che tu non sia Anubi".
"Anubi? Io? Ma come vi è venuta in mente".
"Già, chissà come. Un traghettatore con la testa di cane, guarda un po'".
"Pietro, questo è veramente un colpo basso".
"Anubi traghettava le anime dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Sei sicuro di non saperne niente?"
"Un santo come me, a cui hanno dedicato cattedrali e sagre..."
"La tua festa è il 25 luglio, giusto? La levata eliaca di Sirio, pensa un po'".
"La levata che?"
"Non fare il furbo. La levata eliaca è il giorno dell'anno in cui una stella sorge esattamente all'alba. Nell'antico Egitto la levata di Sirio annunciava la piena estiva del Nilo".
"Molto interessante, ma che c'entro io..."
"Sirio è la stella alfa della costellazione del Cane".
"Costellazione greca, non egiziana".
"Aha! Vedi che queste cose le conosci. Il 25 luglio è l'inizio della canicola, il periodo più caldo dell'anno".
"Io non c'entro niente, io porto il bimbo in spalle, basta".
"Di Anubi si sono perse le tracce con l'arrivo dei Greci. Sappiamo che a un certo punto si è fatto assumere nel loro pantheon come Ermete Psicopompo, l'accompagnatore delle anime. Un autista, praticamente. Però..."
"Non lo conosco".
"...però c'è questo dettaglio intrigante in Apuleio, che parla di un culto di Anubi ancora nel secondo secolo dopo Cristo, a Roma..."
"Wof! Non ci sono prove!"
"Cris, sei sicuro di non essere Anubi, il dio egiziano dei morti, lo sciacallo inventore dell'imbalsamazione?"
"Ma certo che ne sono sicuro".
"Puoi dimostrarlo?"
"Siete voi che dovreste provare il contrario, al massimo".
"Erano tempi un po' particolari, lo sai meglio di me. C'era il calendario vuoto e molti riti pagani ancora ben radicati, e insomma, si cristianizzò tutto molto in fretta e un po' alla benemeglio. Anch'io in fin dei conti ho una barba bianca un po' da Zeus, diciamo. Però sto nei vangeli, sono abbastanza inattaccabile. Ma tu?"
"Io ho un sacco di affreschi..."
"Sei una figura del folklore. Il gigante selvaggio che salva il bambino. Sei anche un topos letterario. Ma non possiamo metterti nei portachiavi. Che figura ci facciamo?"
"Fino all'anno scorso andava tutto bene".
"Siamo nel 1969, l'uomo è andato sulla luna. L'uomo protestante, almeno. Il cattolico deve ancora star lì a credere ai giganti e onorare gli sciacalli del mondo dei morti? Eddai".
"Mentre invece Antonio..."
"È un predicatore, un francescano, un personaggio storico, ha un carnet di miracoli attestati che non finisce più. E poi era cosmopolita, parlava una dozzina di lingue, tu ancora abbai".
"Non abbaio più così tanto".
"È ancora un po' troppo, Cris, mi dispiace".
"Ho guidato Colombo verso il Nuovo Mondo, ricordati".
"Fu una botta di culo, lo sanno tutti".
"E così mi date il benservito".
"Ma non è così... si tratta di aver pazienza, è cominciata questa fase industriale in cui si dà importanza ai documenti, alla scienza... magari passa un secolo e ti ritiriamo fuori, anche con la testa di cane. Lo sai che ci fu un dibattito medievale sui cinocefali, chi diceva che erano anche loro figli di Dio e chi diceva di no?"
"E allora?"
"E allora per certi versi precorreva i tempi, era un dibattito sulla diversità radicale, in seguito abbiamo capito che i cinocefali non esistono, ma ora ci stiamo misurando con diversità sempre maggiori, per dire, metti che incontriamo razze extraterrestri intelligenti, metti che invece di essere primati siano canidi, per dire... A quel punto torni in ballo tu, con la testa originale".
"Mi stai dicendo che devo aspettare degli ET con la testa di cane?"
"Non necessariamente, però in pratica sì, si tratta di aspettare. Sei un archetipo dopotutto. Hai l'eternità davanti".
"Wof".
"E non fare così, su. Non ti ha preso a pedate nessuno".
"Wof".
"Senti. Non ci guarda nessuno. Perché non facciamo un gioco?"
"Wof".
"Io tiro le chiavi e tu me le riporti".
"Arf! Arf! Arf!"
 |
| San Cristoforo e il bambin Gesù, portachiavi |
"Ciao Cristoforo, qual buon vento! Erano secoli che..."
"Taglia corto. Voglio vedere il capo".
"Il... il capo non riceve, mi dispiace".
"Cosa vuol dire che non riceve. Non ha senso. Io gli devo parlare. Adesso".
"Adesso no, Cristoforo, adesso è in... in riunione".
"Ecco. Parliamo di queste riunioni. Cosa sta succedendo là sotto, me lo vuoi spiegare? Cosa stanno combinando?"
"Ma niente... rimettono a posto il calendario, cose che capitano, d'altronde ogni tot secoli una riforma è necessaria, devi pensare che arriva gente nuova in continuazione, e così..."
"E io che c'entro? Forse che ho fatto qualcosa che non va?"
"Ma no Cristoforo, non c'è niente che non vada, però..."
"È vero che mi tolgono il patronato degli automobilisti? Perché? Forse che non li ho protetti?"
"Hai fatto quel che hai potuto, ma..."
"E poi se li tolgono a me a chi li danno, scusa".
"A Sant'Antonio, pare".
"Antonio? L'eremita?"
"Noo. Quello nuovo, il francescano... Antonio di Padova".
"Il ragazzino? E che ha fatto, scusa, che c'entra lui cogli automobilisti".
"L'hanno visto col Bambino in braccio, miracolo attestato in un processo di canonizzazione".
"Col Bambino in braccio? E io allora? Non ce l'ho un affresco col bimbo in spalla in tutte le cattedrali d'Europa?"
"Cristoforo, eddai..."
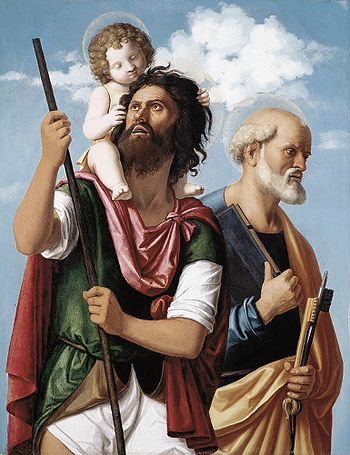 |
| Cima da Conegliano, San Cristoforo col bambino e San Pietro |
"È qui da sette secoli, ormai..."
"Appunto. Una matricola. Io lo sai che sono qui da quando hanno messo in piedi la baracca".
"Forse anche da prima".
"Esatto".
"È un po' questo il problema, Cris. Tu sei veramente un po' antico".
"Arf! Che male c'è?"
"Basta vedere gli affreschi più vecchi, il bambino sembra minuscolo sulle tue spalle".
"Sono un gigante, e allora? Cosa c'è di male?"
"C'è che i giganti non esistono, Cristoforo".
"Che ne sai tu. Una volta, magari..."
"Una volta, una volta. Adesso queste cose si sanno. C'è la paleontologia, l'archeologia. I giganti non sono mai esistiti".
"Magari ero un Neanderthal".
"Eddai Cristoforo, non fare il furbo. È saltata fuori questa cosa imbarazzante della cinocefalia".
"Wof, di che parli?"
"Nelle raffigurazioni più antiche avevi la testa di un cane, Cris"
"Embè?"
"Senti, non è niente di personale. Non è che ti cacceranno proprio... ti toglieranno dalla prima fila del calendario, questo sì".
"Bau! Cosa?"
 "Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi..."
"Per quanto riguarda il patronato degli automobilisti, cerca di capire... è un affare serio, parliamo di un settore in crescita vertiginosa, c'è tutta una gadgettistica che sta fiorendo, calamite, adesivi da parabrezza, portachiavi...""Io mi sono difeso bene, non puoi dire di no".
"Non sto dicendo questo. Però cerca di metterti nei panni del capo. È un ruolo importante. Non possiamo metterci uno che forse all'inizio aveva la testa di cane. Serve un tizio che abbia dei riferimenti storici, uno di cui si possa dimostrare l'esistenza. Mentre tu..."
"Io cosa? Cosa c'è che non va con me?"
"Tu sei una leggenda, Cristoforo, dai".
"Ma siamo tutti leggende, qui..."
"Tu più di altri. Sei un mostro che guada il fiume col bambino sulle spalle. Magari eri una figura mitologica legata a qualche guado di fiume, o il guardiano di un ponte. Sempre che tu non sia Anubi".
"Anubi? Io? Ma come vi è venuta in mente".
"Già, chissà come. Un traghettatore con la testa di cane, guarda un po'".
"Pietro, questo è veramente un colpo basso".
"Anubi traghettava le anime dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Sei sicuro di non saperne niente?"
"Un santo come me, a cui hanno dedicato cattedrali e sagre..."
"La tua festa è il 25 luglio, giusto? La levata eliaca di Sirio, pensa un po'".
"La levata che?"
"Non fare il furbo. La levata eliaca è il giorno dell'anno in cui una stella sorge esattamente all'alba. Nell'antico Egitto la levata di Sirio annunciava la piena estiva del Nilo".
"Molto interessante, ma che c'entro io..."
"Sirio è la stella alfa della costellazione del Cane".
"Costellazione greca, non egiziana".
"Aha! Vedi che queste cose le conosci. Il 25 luglio è l'inizio della canicola, il periodo più caldo dell'anno".
"Io non c'entro niente, io porto il bimbo in spalle, basta".
"Di Anubi si sono perse le tracce con l'arrivo dei Greci. Sappiamo che a un certo punto si è fatto assumere nel loro pantheon come Ermete Psicopompo, l'accompagnatore delle anime. Un autista, praticamente. Però..."
 |
| Chi è Anubi? Bau, bau mai sentito |
"...però c'è questo dettaglio intrigante in Apuleio, che parla di un culto di Anubi ancora nel secondo secolo dopo Cristo, a Roma..."
"Wof! Non ci sono prove!"
"Cris, sei sicuro di non essere Anubi, il dio egiziano dei morti, lo sciacallo inventore dell'imbalsamazione?"
"Ma certo che ne sono sicuro".
"Puoi dimostrarlo?"
"Siete voi che dovreste provare il contrario, al massimo".
"Erano tempi un po' particolari, lo sai meglio di me. C'era il calendario vuoto e molti riti pagani ancora ben radicati, e insomma, si cristianizzò tutto molto in fretta e un po' alla benemeglio. Anch'io in fin dei conti ho una barba bianca un po' da Zeus, diciamo. Però sto nei vangeli, sono abbastanza inattaccabile. Ma tu?"
"Io ho un sacco di affreschi..."
"Sei una figura del folklore. Il gigante selvaggio che salva il bambino. Sei anche un topos letterario. Ma non possiamo metterti nei portachiavi. Che figura ci facciamo?"
"Fino all'anno scorso andava tutto bene".
"Siamo nel 1969, l'uomo è andato sulla luna. L'uomo protestante, almeno. Il cattolico deve ancora star lì a credere ai giganti e onorare gli sciacalli del mondo dei morti? Eddai".
"Mentre invece Antonio..."
"È un predicatore, un francescano, un personaggio storico, ha un carnet di miracoli attestati che non finisce più. E poi era cosmopolita, parlava una dozzina di lingue, tu ancora abbai".
"Non abbaio più così tanto".
 |
| Sant'Antonio e il bambin Gesù, portachiavi |
"Ho guidato Colombo verso il Nuovo Mondo, ricordati".
"Fu una botta di culo, lo sanno tutti".
"E così mi date il benservito".
"Ma non è così... si tratta di aver pazienza, è cominciata questa fase industriale in cui si dà importanza ai documenti, alla scienza... magari passa un secolo e ti ritiriamo fuori, anche con la testa di cane. Lo sai che ci fu un dibattito medievale sui cinocefali, chi diceva che erano anche loro figli di Dio e chi diceva di no?"
"E allora?"
"E allora per certi versi precorreva i tempi, era un dibattito sulla diversità radicale, in seguito abbiamo capito che i cinocefali non esistono, ma ora ci stiamo misurando con diversità sempre maggiori, per dire, metti che incontriamo razze extraterrestri intelligenti, metti che invece di essere primati siano canidi, per dire... A quel punto torni in ballo tu, con la testa originale".
"Mi stai dicendo che devo aspettare degli ET con la testa di cane?"
"Non necessariamente, però in pratica sì, si tratta di aspettare. Sei un archetipo dopotutto. Hai l'eternità davanti".
"Wof".
"E non fare così, su. Non ti ha preso a pedate nessuno".
"Wof".
"Senti. Non ci guarda nessuno. Perché non facciamo un gioco?"
"Wof".
"Io tiro le chiavi e tu me le riporti".
"Arf! Arf! Arf!"
mercoledì 24 luglio 2019
Neanche la morte ride più
Toc toc
"Chi è?"
"La Morte".
"Ma come la morte".
"Dai, fai la tua battutina, avanti".
"Ma in che senso la morte".
"Nel senso che indovini benissimo".
"Ma proprio adesso, qui, insomma, perché?"
"Boh, mica deve esserci un perché. Sarai uscito nelle ore più calde, non ti sarai idratato abbastanza, adesso fa' pure la tua battutina e andiamo avanti".
"Potrebbe esserci un errore, ci sono molti anziani nel vicinato"
"Nessun errore, dai, non facciamola lunga. Allora la fai la tua battutina o no?"
"Ma quale battutina, non capisco".
"Senti ciccio io è da stamattina che falcio su gente e non ho staccato neanche per pranzo, devo averne fatti un centinaio".
"Giornata dura".
"No guarda, giornata nella media, ma non è questo il problema. Il problema è che non ce n'è stato uno, ti dico che non ce n'è stato uno che non ha cercato di farmi la battutina sul Mandato Zero".
"Aaaaah, *quella* battutina, certo,
"E uno dice "è la mia vita-zero", un altro "è la mia esistenza-zero", tutti originalissimi, tutti simpaticissimi, roba da ammazzarli tutti, non fosse già il mio mestiere. Allora la fai la battutina o no?"
"Sì, in effetti stavo cercando la formulazione più efficace..."
"Seh ciao. Ti do quindici anni se non la fai".
"Venti".
"Aggiudicato".
"Gnnnnn".
"Resisti. Morditi la lingua".
"GNNNNNN".
"Pensa ai tuoi cari".
"NON CI RIESCO".
"Va bene dai, me ne vado prima della punchline. Bevi più acqua".
"MA QUINDI ERA DAVVERO LA MIA MORTE-Z..."
"Lalalaà cosa? non ti sento".
"Chi è?"
"La Morte".
"Ma come la morte".
"Dai, fai la tua battutina, avanti".
"Ma in che senso la morte".
"Nel senso che indovini benissimo".
"Ma proprio adesso, qui, insomma, perché?"
"Boh, mica deve esserci un perché. Sarai uscito nelle ore più calde, non ti sarai idratato abbastanza, adesso fa' pure la tua battutina e andiamo avanti".
"Potrebbe esserci un errore, ci sono molti anziani nel vicinato"
"Nessun errore, dai, non facciamola lunga. Allora la fai la tua battutina o no?"
"Ma quale battutina, non capisco".
"Senti ciccio io è da stamattina che falcio su gente e non ho staccato neanche per pranzo, devo averne fatti un centinaio".
"Giornata dura".
"No guarda, giornata nella media, ma non è questo il problema. Il problema è che non ce n'è stato uno, ti dico che non ce n'è stato uno che non ha cercato di farmi la battutina sul Mandato Zero".
"Aaaaah, *quella* battutina, certo,
"E uno dice "è la mia vita-zero", un altro "è la mia esistenza-zero", tutti originalissimi, tutti simpaticissimi, roba da ammazzarli tutti, non fosse già il mio mestiere. Allora la fai la battutina o no?"
"Sì, in effetti stavo cercando la formulazione più efficace..."
"Seh ciao. Ti do quindici anni se non la fai".
"Venti".
"Aggiudicato".
"Gnnnnn".
"Resisti. Morditi la lingua".
"GNNNNNN".
"Pensa ai tuoi cari".
"NON CI RIESCO".
"Va bene dai, me ne vado prima della punchline. Bevi più acqua".
"MA QUINDI ERA DAVVERO LA MIA MORTE-Z..."
"Lalalaà cosa? non ti sento".
sabato 20 luglio 2019
L'Invalsi fa politica, anche se non lo sa
 Se negli ultimi giorni non siete stati completamente assorbiti dal diabolico piano neonazista per uccidere Matteo Salvini, o dal diabolico piano del Pd per rubarvi i figli e darli in adozione ai gay, può darsi che anche voi abbiate sentito parlare dell'ultimo rapporto Invalsi, appena pubblicato. Può darsi che sulle vostre bacheche sia comparso qualche titolo disperato: un terzo degli studenti non sa leggere un brano in italiano! Può darsi che vi siate imbattuti in qualche accigliata riflessione: avete voluto il sei politico e adesso guarda cos'è successo, alle medie non si fa più analisi grammaticale e il risultato è una catastrofe. Può davvero darsi che abbiate letto cose del genere – ebbene, indovinate: non è praticamente vero niente.
Se negli ultimi giorni non siete stati completamente assorbiti dal diabolico piano neonazista per uccidere Matteo Salvini, o dal diabolico piano del Pd per rubarvi i figli e darli in adozione ai gay, può darsi che anche voi abbiate sentito parlare dell'ultimo rapporto Invalsi, appena pubblicato. Può darsi che sulle vostre bacheche sia comparso qualche titolo disperato: un terzo degli studenti non sa leggere un brano in italiano! Può darsi che vi siate imbattuti in qualche accigliata riflessione: avete voluto il sei politico e adesso guarda cos'è successo, alle medie non si fa più analisi grammaticale e il risultato è una catastrofe. Può davvero darsi che abbiate letto cose del genere – ebbene, indovinate: non è praticamente vero niente.Niente. Non solo non risulta a nessuna Procura un complotto neonazista contro Salvini. Non solo non risulta fin qui nessun dirigente Pd indagato denunciato per aver tolto un figlio a un genitore. Non è nemmeno vero che alle medie non si faccia analisi logica e grammaticale: dispiace che Corrado Augias non abbia potuto controllare su un qualsiasi libro di testo, prima di consegnare le sue osservazioni a Repubblica. Quanto al sei politico, è più una leggenda metropolitana che altro: se davvero fu assegnato a qualche classe negli anni Settanta, ormai quegli studenti sono genitori di altri studenti passati attraverso altre quattro riforme scolastiche, tanto vale dare la colpa alla riforma Gentile, se non direttamente a Carlo Magno. Non è nemmeno vero che un terzo degli studenti non sappia leggere un testo: anzi, è proprio un caso di scuola di come un dato statistico possa essere deformato in senso propagandistico, o anche solo perché nelle edicole il titolo allarmista scaccia sempre il titolo accurato.
I test Invalsi sono costruiti proprio per mantenere un terzo del campione al di sotto della media: è quel che prevede il modello teorico che li ispira. Lamentarsi che un terzo dei candidati non superi la media è un po' come denunciare la scarsa qualità del tennis giocato a Wimbledon perché su 128 iscritti solo la metà riesce a passare il primo turno. Senz'altro la comprensione del testo di troppi studenti medi italiani lascia ancora a desiderare, ma di fronte a un giornalismo del genere sorge il dubbio che sia il minore dei mali: che senso ha imparare a leggere meglio se poi quel che c'è da leggere in edicola è una rifrittura delle stesse opinioni stantie prodotte entro il 1989 e poi chiuse in un cassetto? Chi ha ancora necessità di leggere attacchi a fantasmi polemici come il "6 politico", il famigerato "Sessantotto", una mai meglio definita "didattica delle competenze", eccetera eccetera eccetera?
E dire che l'Invalsi per primo fa tutto il possibile per stimolare una discussione più interessante. Il rapporto somiglia a una brochure pubblicitaria, i grafici sono abbastanza chiari, gli argomenti scelti con molta attenzione. Oltre a valutare la scuola pubblica nel suo complesso, l'Invalsi ogni anno valuta sé stessa e non è una sorpresa che si promuova sempre. Chi la vuole criticare senza indulgere ai luoghi comuni si trova invece in difficoltà: un po' perché la mole di dati a disposizione è effettivamente abbondante; un po' perché comunque conosciamo solo i dati che l'Invalsi vuole farci conoscere. Per dire: l'insegnante che ha trovato la domanda X un po' assurda non ha la possibilità di verificare se i suoi studenti siano riusciti comunque a rispondere in modo soddisfacente. In compenso ha tutti i dati a disposizione per osservare i fenomeni che l'Invalsi vuole farci osservare.
Ad esempio: la parola chiave di quest'anno è senz'altro "divario". Divario tra generi (i maschi vanno meglio in matematica, le femmine in inglese), divario tra le regioni: il nord ha risultati migliori della media, il sud inferiori. Nulla di nuovo o sorprendente, e infatti una critica che si può muovere all'Invalsi è che ci fa spendere molti soldi per dirci qualcosa che in sostanza sapevamo già: nelle zone in cui il reddito pro capite è più alto, anche l'offerta formativa è migliore. Lo strumento che secondo alcuni dovrebbe servire a valutare i docenti finisce per suggerire che la possibilità dei docenti di fare la differenza sia scarsa o nulla: un insegnante scarso a Nord avrà comunque studenti più brillanti di un insegnante motivato a Sud. Nei rari casi in cui questo non succede, il meccanismo dell'Invalsi di solito non individua un insegnante meritorio, ma un insegnante disonesto che trucca i risultati. Un fenomeno, il cosiddetto cheating, che negli ultimi due anni si è bruscamente ridotto, ci avverte l'Invalsi, senza fornirci spiegazioni. Ne azzardo una io, almeno per quanto riguarda la prova di terza secondaria di primo grado: fino a due anni fa si somministrava durante l'esame di licenza e faceva media, il che esponeva gli studenti a un rischio di bocciatura e i consigli di classe al rischio di contestazioni e ricorsi. Dal 2018 la prova si fa in primavera e non fa più media: inoltre è finalmente computer based, ovvero gli insegnanti non la correggono più a mano (finalmente!), e quindi non potrebbero truccare i risultati nemmeno se volessero. In compenso la prova non è più ritenuta importante dagli studenti che a volte di fronte all'ennesimo quesito a crocette possono cedere alla tentazione di rispondere a caso. Il fatto un un terzo degli studenti non abbia risposto in modo soddisfacente a un questionario di comprensione di un testo in effetti si potrebbe anche formulare così: un terzo degli studenti non ha capacità o voglia di mettere le crocette nelle caselle giuste. Dove l'Invalsi registra un problema di competenze, un insegnante sul campo potrebbe anche riconoscere un problema di motivazione, e più spesso un composto dei due (chi volesse provare una simulazione delle prove al computer le trova qui: sono meno facili di quel che possono sembrare a prima vista).
Il fatto che anche gli insegnanti non abbiano più la necessità o l'opportunità di sabotare le prove Invalsi non significa che abbiano superato un generale atteggiamento di diffidenza... (continua su The Vision) che è poi la naturale reazione di una categoria a uno strumento imposto dall’alto senza discussioni. È anche vero che in molti casi questa diffidenza assume forme irrazionali: il ministero vuole sostituirci coi computer! Al luddismo dei docenti, l’Invalsi contrappone un entusiasmo positivista che a volte lascia perplessi. Gli esperti e i tecnici dell’ente ministeriale sembrano genuinamente convinti che tre o quattro test abbastanza brevi, quasi tutti a crocette, possano “certificare le competenze”. È la stessa pretesa dei test PISA promossi a livello internazionale dall’OCSE, che però sono più articolati e presentano più quesiti a risposta aperta, quel tipo di domande che meglio consentono all’insegnante di comprendere fino a che punto lo studente ha compreso la domanda (o se si è limitato a copiare la risposta dal compagno). Sappiamo tutti benissimo che le risposte aperte funzionano meglio, così come sappiamo che sono quelle che richiedono più impegno da parte dell’insegnante che corregge, e che sono le più complicate da elaborare meccanicamente: possono funzionare in test somministrati a campione (come appunto quelli OCSE-PISA), mentre creerebbero troppi problemi in un test somministrato a tutta la popolazione scolastica. A chi critica questo aspetto viene fatto notare che comunque i risultati dell’Invalsi non si discostano più di tanto da quelli OCSE-PISA, ma il punto è esattamente questo: se l’Invalsi non fa che scoprire le stesse cose che sappiamo già, viene da chiedersi che senso abbia spenderci così tanto.
Sotto l’impianto scientifico, alcuni insegnanti sospettano che l’Invalsi sia più propaganda che scienza: ogni estate ci ricorda che la scuola va male, e a Sud molto peggio che a Nord. Si sapeva già, ma è comunque utile ribadire. Utile a chi? In tempi di egemonia progressista poteva essere un buon argomento per ispirare investimenti cospicui nelle scuole del Sud. Oggi che sovranismo e localismi vanno per la maggiore e al MIUR siede un leghista, i risultati Invalsi possono essere ugualmente sbandierati da chi chiede la regionalizzazione della scuola (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna): la scuola del Sud è spacciata, tanto vale lasciarla al suo destino.
Alcuni insegnanti temono esattamente questo: l’insistenza con cui l’Invalsi qualche anno fa sottolineava i fenomeni di cheating in meridione, e oggi punta il dito sul divario tra i risultati del Sud e quelli del Nord, è funzionale a un preciso discorso di delegittimazione. Quando un insegnante che lavora in un contesto disagiato decide di dare un 10 e lode a un suo studente, è possibile che in quel voto rientri anche una considerazione soggettiva sulle capacità del ragazzo di ottenere risultati in condizioni avverse. Poi arriva l’Invalsi, somministra un test a crocette, incrocia i dati, e rivela a tutti che il 10 e lode di quel contesto disagiato vale come un 7 di una ricca città padana. Lo dice la scienza, eh: i docenti che brontolano hanno senz’altro paura di perdere i loro privilegi. Proprio mentre domanda equità, l’Invalsi non si rende conto di fornire argomenti a chi la ostacola. Magari i test sono davvero uno strumento scientifico, ma questo non impedisce a nessuno di brandirli per fare politica. Nessuno strumento scientifico, per quanto sofisticato, può controllare la mano che lo impugna.
giovedì 18 luglio 2019
Gramellini, in mancanza di senso
– Perché non dormi.
– Ma no, niente.
– A cosa stai pensando.
– Ma è una cazzata, dai.
– Io la conosco quella faccia.
– Non vale neanche la pena di parlarne guarda.
– Stai pensando a Gramellini.
– ...Cazzo, sì.
– Cos'ha scritto stavolta?
– Ma è una cosa che non... boh... insomma ha definito Stella McCartney una "stilista per mancanza di prove".
– Una che?
– "Stilista per mancanza di prove".
– Ma in che senso?
– Non lo so.
– Cioè non ci sono le prove che lei è stilista? Fa due sfilate l'anno, ci sono le foto, le recensioni...
– Ma anche se non ci fossero, sarebbe stilista proprio per questo, proprio perché mancano le prove, capisci.
– No in realtà non capisco.
– Neanch'io maledizione. Ci sto perdendo il sonno! "Stilista per mancanza di prove".
– Stava cercando di essere ironico.
– Grazie al cazzo, ma in che modo? Qual era il sottotesto, la premessa, non si capisce. Sembra una frase generata a caso.
– Dici che è andato in vacanza e al suo posto hanno messo un bot che cerca di essere ironico piazzando frasi a caso?
– È un'ipotesi, ma non regge. Figurati se un bot non riuscirebbe a essere più ironico di Gramellini.
– Stilista per mancanza di prove.
– Io divento matto.
– Forse è un lapsus, forse intendeva "in mancanza di meglio", cioè non c'erano più posti al gran banchetto della vita e Stella McCartney si è rassegnata a fare la stilista.
– Ma non ha senso. Tutti sognano di fare gli stilisti.
– Non deve avere così senso, è Gramellini.
– Giornalista in mancanza di meglio.
– O in mancanza di prove. Dormi.
– Ma no, niente.
– A cosa stai pensando.
– Ma è una cazzata, dai.
– Io la conosco quella faccia.
– Non vale neanche la pena di parlarne guarda.
– Stai pensando a Gramellini.
– ...Cazzo, sì.
– Cos'ha scritto stavolta?
– Ma è una cosa che non... boh... insomma ha definito Stella McCartney una "stilista per mancanza di prove".
– Una che?
– "Stilista per mancanza di prove".
– Ma in che senso?
– Non lo so.
– Cioè non ci sono le prove che lei è stilista? Fa due sfilate l'anno, ci sono le foto, le recensioni...
– Ma anche se non ci fossero, sarebbe stilista proprio per questo, proprio perché mancano le prove, capisci.
– No in realtà non capisco.
– Neanch'io maledizione. Ci sto perdendo il sonno! "Stilista per mancanza di prove".
– Stava cercando di essere ironico.
– Grazie al cazzo, ma in che modo? Qual era il sottotesto, la premessa, non si capisce. Sembra una frase generata a caso.
– Dici che è andato in vacanza e al suo posto hanno messo un bot che cerca di essere ironico piazzando frasi a caso?
– È un'ipotesi, ma non regge. Figurati se un bot non riuscirebbe a essere più ironico di Gramellini.
– Stilista per mancanza di prove.
– Io divento matto.
– Forse è un lapsus, forse intendeva "in mancanza di meglio", cioè non c'erano più posti al gran banchetto della vita e Stella McCartney si è rassegnata a fare la stilista.
– Ma non ha senso. Tutti sognano di fare gli stilisti.
– Non deve avere così senso, è Gramellini.
– Giornalista in mancanza di meglio.
– O in mancanza di prove. Dormi.
mercoledì 17 luglio 2019
Alessio, il finto povero
17 luglio – Sant’Alessio (V secolo), povero di rango
[2018]. Lo trovarono secco nel sottoscala, il mendicante, nella casa del patrizio che diciassette anni prima gli aveva dato riparo. “Anche mio figlio, come te, è in giro per il mondo”, gli aveva detto: “ovunque sia, prego che un altro padre gli dia un tetto e un giaciglio per dormire”. Quando l’ospite morì, e furono per raccogliere dal pavimento le sue ossa irrigidite, si accorsero che la mano stringeva un cartiglio, e che c’era scritto qualcosa; ma non si riusciva a leggere, il morto non mollava la pergamena.
Ci provarono i medici ad aprirgli la mano, i pompieri e i pretoriani, ormai era diventata una specie di sfida. Alla fine chiamarono gli imperatori Arcadio e Onorio, tutti e due, perché l’autore della leggenda probabilmente non era sicuro su quale imperasse a Roma e quale a Costantinopoli; e in effetti probabilmente all’inizio la storia era ambientata nella nuova Roma sul Bosforo, ma poi un copista si confuse, probabilmente un locale, sai come la pensano: di Roma ce n’è una sola, hai voglia a spiegare che ce ne sono almeno tre. In una versione successiva interviene il Papa direttamente, così è chiaro in quale Roma siamo. Dunque ecco arriva il Papa in questo palazzo sull’Aventino, ah ma quindi è in questa casa che dormiva quel sant’uomo del mendicante? Gli volevano tutti tanto bene. Cos’avete detto che ha nella mano? Un cartiglio? Ecco qui (la mano morta si apre senza fatica). C’è scritto… c’è scritto che si chiama Alessio e che ringrazia suo padre per l’ospitalità.
Al padrone di casa si ferma il cuore.
Il papa all’improvviso si rammenta. “Ma tu avevi un figlio che si chiamava Alessio, no? Quello che mollò la fidanzata davanti all’altare, quando fu? Trent’anni fa? Ma non se n’era andato per il mondo?”
“Alessio, figlio mio”.
“Vuoi dire che per tutto questo tempo non l’hai riconosciuto?”
“Figlio mio!”
“Anche lui però poteva dirti qualcosa, eh”.
Di tutti i santi del calendario, Alessio è forse quello che capisco meno. Tutti i suoi atti di eroica santità, ai miei occhi di abitante del 21esimo secolo, mi sembrano un mix indigeribile di ingenuità e stronzaggine. Mollare la sposa all’ultimo momento perché Dio è più importante? ok, può succedere a tutti di cambiare idea all’ultimo momento, per fortuna lei ti capisce, condivide la tua scelta di castità e si fa monaca, a questo punto perché non dovresti farti monaco anche tu? No, tu te ne scappi via, beh, posso capire anche questo. Decidi di dare tutto quello che possiedi ai poveri, molto giusto, salvo che sei andato via senza un soldo e quindi sei povero anche tu: se fossi rimasto a casa dei tuoi almeno avresti avuto a disposizione un budget da destinare in imprese benefiche, microcredito eccetera, e invece niente: vuoi combattere la povertà con la povertà, una di quelle cose omeopatiche. Ti è mai venuto in mente che invece potevi metterti a lavorare? In fondo sei un giovane sano, puoi benissimo trovarti un mestiere e poi elargire elemosine a tutti i poveri che incontri, il Vangelo si rispetta anche così – eh, no, dopotutto sei un patrizio romano, o campi nel lusso o fai l’elemosina, ma lavorare è fuori discussione.
A un angolo di strada di Edessa di Siria, dove potrebbe stazionare un povero vero, uno che ha problemi seri, un cieco, uno storpio, un lebbroso ci vai tu che per affettare la miseria non ti lavi per anni; e l’espediente funziona, la gente ti annusa e caccia i pezzi d’argento, che poi nottetempo tu dividi davvero coi poveri, e vabbè, se questo è il posto che ti sei trovato nel mondo buon per te; ma a quel punto che fai? Decidi di tornare a Roma. La nostalgia, posso capire. Ma incontri tuo padre e non gli dici chi sei. Ti fai ospitare 17 anni da tuo padre, tuo padre che è in pensiero per te e si torce il cuore all’idea che tu sei in giro per il vasto mondo senza un soldo ed è sicuramente colpa sua, è stato il padre peggiore del mondo, se solo potesse avere una seconda possibilità, e tu stai lì per 17 anni e questa seconda possibilità non gliela dai.
 E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.
E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.
Talmente stronzo che sembri vero. Cioè qui non parliamo di draghi che rapiscono fanciulle o dormienti in una grotta o martiri che accarezzano i leoni; qui c’è un hippy di buona famiglia che sembra stato ritratto l’altro ieri. Figurati se non ce n’è stato almeno uno a Roma o Costantinopoli od ovunque, figurati se in mille anni non è mai successo che un giovinastro mollasse la famiglia per fare il barbone, in teoria in giro per il mondo ma ben presto a pochi metri dalla casa dei genitori. I quali magari a un certo punto si erano impietositi e lo ospitavano pure nella mansarda a uso foresteria, magari fingendo di non riconoscerlo perché il ragazzo ha un suo distorto senso della dignità, che non gli impedisce di chiedere scusa a mamma e papà ma non di chiedere moneta sotto il loro portico di casa. Magari ce n’è stato uno sia a Edessa che a Bisanzio che a Roma, che si svegliavano presto senza mettere a posto la cameretta e uscivano in strada a mendicare, e alla fine che gli vuoi dire? Dopo un po’ sei parte del paesaggio urbano, il giorno che non ti vedono sulla panchina si preoccupano.
La leggenda di Sant’Alessio, che io trovo tanto stronza, era una delle più popolari nell’Alto Medioevo. Serviva probabilmente a spiegare che in ogni mendicante ci potrebbe essere un principe, e quindi come tale va trattato; o anche più di un principe: un figlio nostro. Nei tempi in cui capitava a tutti di aver figli in giro per il mondo, su barchette sospesa sui flutti del Mediterraneo o intruppati in qualche legione a portare la pace dove ancora non la sapevano apprezzare; ma ovunque si fossero perduti, avrebbero potuto contare sull’ospitalità, che è la legge più antica. E che ci riguarda tutti, uomini di terra o di mare: se qualcuno è senza tetto, è figlio nostro. Anche se non fosse mai esistito un Alessio, a un certo punto la leggenda ne produsse almeno uno: il primo che mi viene in mente è San Benedetto Labre, un ragazzo francese che nel Settecento arrivò a Roma a piedi senza lavarsi mai, la sua Vita sembra un servizio di Chi l’ha visto. I romani lo presero in simpatia, decisero che era un santo e che faceva i miracoli. Si vede che sotto i pidocchi era un bel ragazzo, ma in un certo senso aveva il terreno preparato dalla storia di Sant’Alessio. Ma io lo so cosa state pensando, voi tre che siete arrivati fin qui.
Pensate: ma quindi viviamo nell’epoca più selvaggia, quella che ha rinnegato persino i principi basilari di umanità espressi nelle leggende medievali? Cosa ci è successo? Niente di così nuovo in realtà. Sant’Alessio non è sempre stato così popolare: in alcuni secoli lo era, in altri no, la percezione del mendicante è cambiata spesso nel corso della Storia. Persino l’Odissea, il libro che mette per iscritto la legge dell’ospitalità nei confronti dei viaggiatori (chi non la rispetta è un antropofago, un mostro senza abbastanza occhi per vedere): persino l’Odissea nella seconda parte nel finale diventa una storia molto diversa, forse lievemente più tarda, un libro in cui gli ospiti puzzano, si azzeccano, mangiano bevono e non vogliono saperne di sloggiare, bisognerebbe farli fuori tutti, ruspa! Anzi no, arco e frecce e nessuna pietà.
L’oscillazione che conosco meglio è quella avvenuta tra i secoli XIII e XIV. Nel Duecento, il secolo d’oro della civiltà comunale, il povero diventa un modello. Più i borghesi metton pancia e vestono elegante, più le strade e i sentieri si riempiono di gente che vuole essere povera non per necessità, ma perché la povertà è un valore. Il pauperismo diventa uno stile di vita, un’ideologia, la Chiesa corre al riparo, brucia un po’ di rivoluzionari come eretici e poi cerca di irregimentare le frange moderate: nascono gli Ordini Mendicanti, che sono poveri perché il Papa glielo ha concesso. In mezzo a tutto questo, gli uomini del Duecento continuano a considerare il poveraccio come un’immagine di Cristo, un modello di vita e un figlio da ospitare.
Ma poi arriva il Trecento, la popolazione è aumentata un po’ troppo rispetto alle risorse, le carestie sono sempre più frequenti. La percezione del povero cambia altrettanto repentinamente. L’accattonaggio diventa un reato, i mendicanti vengono incatenati e condotti ai lavori forzati. Non sono più principi in incognito, ma minacce per la società costituita. In effetti spostandosi di città in città non è escluso che diffondano le epidemie: a metà secolo la peste nera falcidia più di un terzo della popolazione. Ritrovarsi per strada senza un soldo nel Trecento era molto più pericoloso che nel secolo precedente. È un esempio che mi ha sempre fatto pensare, forse perché ho spesso avuto la sensazione di vivere in uno di quei passaggi difficili, come tra Duecento e Trecento: i ricchi ingrassano, i poveri aumentano, la classe media perde coscienza di sé, gli artisti si rifugiano nel mercato del lusso e così via. Tutto già previsto e prevedibile.
 Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.
Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.
E siccome crediamo di avere una morale tutta nostra, e non ereditata dall’ambiente o determinata dal reddito, ci crediamo in diritto di farla agli altri, che dovrebbero essere più buoni, più ospitali, meno egoisti, meno preoccupati per catastrofi che in effetti non sempre accadono, in fondo chi mai potrebbe pensare che l’umanità stia di nuovo finendo le risorse a disposizione? E ci preoccupiamo, quanto ci preoccupiamo di quel che penseranno i posteri di noi: ma i posteri non è che avranno sempre tempo o voglia di processarci. Probabilmente penseranno quello che pensiamo noi degli europei del Trecento: che eravamo sostanzialmente dei poveracci, terrorizzati dall’idea di perdere quel po’ di benessere accumulato dai genitori, smarriti di fronte a segnali di catastrofe che non sapevamo interpretare. E che per quanto superstiziosi, per quanto ignoranti, i peggiori di noi avevano capito quello che gli economisti patentati fino a qualche anno prima si rifiutavano di accettare, ovvero: non si può crescere all’infinito, magari sul grande grafico della Storia una curva può venire un po’ più ampia di un’altra, ma prima o poi si riabbassa, è la sua natura. Sant’Alessio, fossi vissuto un po’ più a monte della curva, mi sarebbe riuscito un po’ più simpatico, un proto-San-Francesco integerrimo e giramondo. Ma non ci posso fare niente, io invece vivo nel 2018 e non lo sopporto, mi sembra la caricatura di un hipster che si fa morire di stenti per fare un dispetto al padre. Invece di salire quelle scale e dirgli scusa, papà, mi sono sbagliato, insegnami un mestiere, ai poveri poi manderò un vaglia. Li aiuterò a casa loro.
 |
| Un mendicante a Manchester, nel 2015. (Christopher Furlong/Getty Images) |
Ci provarono i medici ad aprirgli la mano, i pompieri e i pretoriani, ormai era diventata una specie di sfida. Alla fine chiamarono gli imperatori Arcadio e Onorio, tutti e due, perché l’autore della leggenda probabilmente non era sicuro su quale imperasse a Roma e quale a Costantinopoli; e in effetti probabilmente all’inizio la storia era ambientata nella nuova Roma sul Bosforo, ma poi un copista si confuse, probabilmente un locale, sai come la pensano: di Roma ce n’è una sola, hai voglia a spiegare che ce ne sono almeno tre. In una versione successiva interviene il Papa direttamente, così è chiaro in quale Roma siamo. Dunque ecco arriva il Papa in questo palazzo sull’Aventino, ah ma quindi è in questa casa che dormiva quel sant’uomo del mendicante? Gli volevano tutti tanto bene. Cos’avete detto che ha nella mano? Un cartiglio? Ecco qui (la mano morta si apre senza fatica). C’è scritto… c’è scritto che si chiama Alessio e che ringrazia suo padre per l’ospitalità.
Al padrone di casa si ferma il cuore.
| Ritrovamento del corpo di sant’Alessio, XVIII secolo |
“Alessio, figlio mio”.
“Vuoi dire che per tutto questo tempo non l’hai riconosciuto?”
“Figlio mio!”
“Anche lui però poteva dirti qualcosa, eh”.
Di tutti i santi del calendario, Alessio è forse quello che capisco meno. Tutti i suoi atti di eroica santità, ai miei occhi di abitante del 21esimo secolo, mi sembrano un mix indigeribile di ingenuità e stronzaggine. Mollare la sposa all’ultimo momento perché Dio è più importante? ok, può succedere a tutti di cambiare idea all’ultimo momento, per fortuna lei ti capisce, condivide la tua scelta di castità e si fa monaca, a questo punto perché non dovresti farti monaco anche tu? No, tu te ne scappi via, beh, posso capire anche questo. Decidi di dare tutto quello che possiedi ai poveri, molto giusto, salvo che sei andato via senza un soldo e quindi sei povero anche tu: se fossi rimasto a casa dei tuoi almeno avresti avuto a disposizione un budget da destinare in imprese benefiche, microcredito eccetera, e invece niente: vuoi combattere la povertà con la povertà, una di quelle cose omeopatiche. Ti è mai venuto in mente che invece potevi metterti a lavorare? In fondo sei un giovane sano, puoi benissimo trovarti un mestiere e poi elargire elemosine a tutti i poveri che incontri, il Vangelo si rispetta anche così – eh, no, dopotutto sei un patrizio romano, o campi nel lusso o fai l’elemosina, ma lavorare è fuori discussione.
A un angolo di strada di Edessa di Siria, dove potrebbe stazionare un povero vero, uno che ha problemi seri, un cieco, uno storpio, un lebbroso ci vai tu che per affettare la miseria non ti lavi per anni; e l’espediente funziona, la gente ti annusa e caccia i pezzi d’argento, che poi nottetempo tu dividi davvero coi poveri, e vabbè, se questo è il posto che ti sei trovato nel mondo buon per te; ma a quel punto che fai? Decidi di tornare a Roma. La nostalgia, posso capire. Ma incontri tuo padre e non gli dici chi sei. Ti fai ospitare 17 anni da tuo padre, tuo padre che è in pensiero per te e si torce il cuore all’idea che tu sei in giro per il vasto mondo senza un soldo ed è sicuramente colpa sua, è stato il padre peggiore del mondo, se solo potesse avere una seconda possibilità, e tu stai lì per 17 anni e questa seconda possibilità non gliela dai.
 E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.
E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbè ma allora vaffanculo, Sant’Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco.Talmente stronzo che sembri vero. Cioè qui non parliamo di draghi che rapiscono fanciulle o dormienti in una grotta o martiri che accarezzano i leoni; qui c’è un hippy di buona famiglia che sembra stato ritratto l’altro ieri. Figurati se non ce n’è stato almeno uno a Roma o Costantinopoli od ovunque, figurati se in mille anni non è mai successo che un giovinastro mollasse la famiglia per fare il barbone, in teoria in giro per il mondo ma ben presto a pochi metri dalla casa dei genitori. I quali magari a un certo punto si erano impietositi e lo ospitavano pure nella mansarda a uso foresteria, magari fingendo di non riconoscerlo perché il ragazzo ha un suo distorto senso della dignità, che non gli impedisce di chiedere scusa a mamma e papà ma non di chiedere moneta sotto il loro portico di casa. Magari ce n’è stato uno sia a Edessa che a Bisanzio che a Roma, che si svegliavano presto senza mettere a posto la cameretta e uscivano in strada a mendicare, e alla fine che gli vuoi dire? Dopo un po’ sei parte del paesaggio urbano, il giorno che non ti vedono sulla panchina si preoccupano.
 |
| Nausicaa s’imbatte sulla spiaggia in un migrante economico. |
Pensate: ma quindi viviamo nell’epoca più selvaggia, quella che ha rinnegato persino i principi basilari di umanità espressi nelle leggende medievali? Cosa ci è successo? Niente di così nuovo in realtà. Sant’Alessio non è sempre stato così popolare: in alcuni secoli lo era, in altri no, la percezione del mendicante è cambiata spesso nel corso della Storia. Persino l’Odissea, il libro che mette per iscritto la legge dell’ospitalità nei confronti dei viaggiatori (chi non la rispetta è un antropofago, un mostro senza abbastanza occhi per vedere): persino l’Odissea nella seconda parte nel finale diventa una storia molto diversa, forse lievemente più tarda, un libro in cui gli ospiti puzzano, si azzeccano, mangiano bevono e non vogliono saperne di sloggiare, bisognerebbe farli fuori tutti, ruspa! Anzi no, arco e frecce e nessuna pietà.
 | |||
|
Ma poi arriva il Trecento, la popolazione è aumentata un po’ troppo rispetto alle risorse, le carestie sono sempre più frequenti. La percezione del povero cambia altrettanto repentinamente. L’accattonaggio diventa un reato, i mendicanti vengono incatenati e condotti ai lavori forzati. Non sono più principi in incognito, ma minacce per la società costituita. In effetti spostandosi di città in città non è escluso che diffondano le epidemie: a metà secolo la peste nera falcidia più di un terzo della popolazione. Ritrovarsi per strada senza un soldo nel Trecento era molto più pericoloso che nel secolo precedente. È un esempio che mi ha sempre fatto pensare, forse perché ho spesso avuto la sensazione di vivere in uno di quei passaggi difficili, come tra Duecento e Trecento: i ricchi ingrassano, i poveri aumentano, la classe media perde coscienza di sé, gli artisti si rifugiano nel mercato del lusso e così via. Tutto già previsto e prevedibile.
 Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.
Anche la nostra insofferenza nei confronti dei mendicanti non è un fenomeno inedito. Quel senso di vergogna che ci sembra così personale, così intimo, quando avvistiamo un’accattona col piattino sotto il portico e tiriamo dritto: anche quel senso di vergogna è una variabile fortemente correlata ad altre funzioni sociali misurabili con un certo margine di errore, per esempio nelle fasi di crescita economica il povero viene trattato meglio, talvolta idealizzato, è il momento in cui Claudio Lolli vede gli zingari felici e Bob Dylan si traveste da gitano sulla copertina di Desire. Probabilmente c’è una correlazione tra il PIL e l’apprezzamento per la musica balcanica, perché vi giuro che c’era un periodo che Bregovic tirava da matti qui da noi, mentre oggi è universalmente disprezzata e bandita anche dal congresso annuale dei poveri, il Concertone del primo maggio. Noi poi siamo convinti che sia tutto relativo, tranne noi. Pensiamo di avere una morale indipendente dalle nostre coordinate geografiche, storiche, sociali; magari siamo comunisti o femministi o vegetariani e siamo convinti che lo saremmo stati anche se fossimo nati a Bisanzio nel V secolo. Tutti convinti di saperci giocare sapientemente le carte che il destino ci ha messo in mano, come se la vita fosse uno scopone scientifico e non un triviale rubamazzo.E siccome crediamo di avere una morale tutta nostra, e non ereditata dall’ambiente o determinata dal reddito, ci crediamo in diritto di farla agli altri, che dovrebbero essere più buoni, più ospitali, meno egoisti, meno preoccupati per catastrofi che in effetti non sempre accadono, in fondo chi mai potrebbe pensare che l’umanità stia di nuovo finendo le risorse a disposizione? E ci preoccupiamo, quanto ci preoccupiamo di quel che penseranno i posteri di noi: ma i posteri non è che avranno sempre tempo o voglia di processarci. Probabilmente penseranno quello che pensiamo noi degli europei del Trecento: che eravamo sostanzialmente dei poveracci, terrorizzati dall’idea di perdere quel po’ di benessere accumulato dai genitori, smarriti di fronte a segnali di catastrofe che non sapevamo interpretare. E che per quanto superstiziosi, per quanto ignoranti, i peggiori di noi avevano capito quello che gli economisti patentati fino a qualche anno prima si rifiutavano di accettare, ovvero: non si può crescere all’infinito, magari sul grande grafico della Storia una curva può venire un po’ più ampia di un’altra, ma prima o poi si riabbassa, è la sua natura. Sant’Alessio, fossi vissuto un po’ più a monte della curva, mi sarebbe riuscito un po’ più simpatico, un proto-San-Francesco integerrimo e giramondo. Ma non ci posso fare niente, io invece vivo nel 2018 e non lo sopporto, mi sembra la caricatura di un hipster che si fa morire di stenti per fare un dispetto al padre. Invece di salire quelle scale e dirgli scusa, papà, mi sono sbagliato, insegnami un mestiere, ai poveri poi manderò un vaglia. Li aiuterò a casa loro.
martedì 16 luglio 2019
L'arcivescovo in guêpière
16 luglio – San Vitaliano di Capua (VII sec.), un vescovo molto distratto.
A San Vitaliano capitò, verso la fine del settimo secolo, di svegliarsi molto presto, come tutti i giorni, per il servizio mattutino; di intonare i salmi in cattedrale con gli occhi probabilmente ancora incispati di sonno; e di cominciare a udire, negli intervalli tra inno e responsorio, qualche risolino sempre meno imbarazzato, finché non capì che stava succedendo qualcosa di veramente terribile; e solo in quel momento aprì gli occhi davvero; e solo in quel momento si accorse che era vestito da donna.
Da donna come?
La leggenda non lo dice! e quindi siamo liberi di sfrenarci: reggicalze, guêpière, eccetera. Anche se più probabilmente era un semplice sottanone, neanche troppo diverso da quelli che veste un prete: ma siamo nel settimo secolo, quasi ottavo, qualsiasi indumento femminile in quella situazione sarebbe risultato piuttosto conturbante.
Bisogna anche dire che il mattutino si cantava molto presto: prima dell’alba. Con tutto questo, per arrivare vestiti da donna in cattedrale ci vuole una certa disattenzione. Vale la pena di ricordare ancora una volta che il travestitismo fu ritenuto per tutto il medioevo un peccato gravissimo (carnevale a parte), e che l'unica prova veramente trovata per bruciare Giovanna d’Arco come strega fu il fatto che si era messa in pantaloni. In seguito Vitaliano riuscì a dimostrare che si era vestito così a sua insaputa: alcuni suoi nemici, preti invidiosi che mal digerivano la sua popolarità presso i fedeli capuani, gli avrebbero sostituito nottetempo i paramenti sacri con abiti femminei; Vitaliano poi era uno di quelli che al mattino si vestono alla cieca, senza neanche accendere il lume, e così… in fondo sempre gonne sono, no? Devo dire che non è così implausibile. Meno di un vescovo col fetish degli indumenti femminili? Non saprei.
La prima reazione di Vitaliano fu darsela a gambe in direzione Roma, dove il Papa lo avrebbe senz’altro capito e sostenuto. Ma i preti invidiosi lo inseguivano e lo catturarono all’altezza di Mondragone: lo ficcarono in un sacco e lo buttarono a mare, incuranti delle mille altre leggende in cui i santi insaccati e affogati la fanno franca. E infatti, mentre Vitaliano approdava senza grosse difficoltà a Ostia e decideva di trascorrerci le vacanze, a Capua cominciarono a infuriare carestie e pestilenze. La gente mormorava: rivogliamo Vitaliano, anche in tacchi e reggipetto. Torna Vitaliano! Ti capiamo! Chi non ha mai infilato una giarrettiera anche solo per l’effetto che fa, scagli il primo tacco dodici. No.
Mi sto inventando.
È estate, dai.
Ma insomma rivolevano tutti ardentemente Vitaliano, e Vitaliano… non tornò. Cioè, sì, ma appena per un’ospitata di una sera – più che sufficiente a far piovere e ad allontanare il morbo. Ma non si fermò, si vede che non si sentiva più a suo agio; e forse presagiva la fine. Si ritirò in eremitaggio presso due o tre cime diverse – c’è sempre un po’ di concorrenza – nei pressi di Caserta o forse più verso Avellino, dove il Monte Virgiliano fu ribattezzato, in suo onore, Montevergine. E dove poteva anche infilare un paio di mutandine di pizzo sotto il cilicio senza che nessuno avesse niente da dire.
In occasione della sua festa, gli abitanti di Capua si vestono tutti da donne comprese le donne, e poi si abbracciano e si baciano fino al mattutino e anche oltre. No.
Mi sto inventando.
Ma sarebbe divertente, insolito, e credo che gioverebbe anche al turismo, insomma io se fossi nella pro loco ci farei un pensiero. Vitaliano è patrono di tutti gli uomini molto sbadati o che fanno finta, e che si vestono al buio e certe volte arrivano a lavorare con delle mises che ma ti sei visto? Eh, no, scusa, ancora no…. Mado’ che vergogna… San Vitaliano proteggimi.
 |
| Che patrono del cacchio |
Da donna come?
La leggenda non lo dice! e quindi siamo liberi di sfrenarci: reggicalze, guêpière, eccetera. Anche se più probabilmente era un semplice sottanone, neanche troppo diverso da quelli che veste un prete: ma siamo nel settimo secolo, quasi ottavo, qualsiasi indumento femminile in quella situazione sarebbe risultato piuttosto conturbante.
Bisogna anche dire che il mattutino si cantava molto presto: prima dell’alba. Con tutto questo, per arrivare vestiti da donna in cattedrale ci vuole una certa disattenzione. Vale la pena di ricordare ancora una volta che il travestitismo fu ritenuto per tutto il medioevo un peccato gravissimo (carnevale a parte), e che l'unica prova veramente trovata per bruciare Giovanna d’Arco come strega fu il fatto che si era messa in pantaloni. In seguito Vitaliano riuscì a dimostrare che si era vestito così a sua insaputa: alcuni suoi nemici, preti invidiosi che mal digerivano la sua popolarità presso i fedeli capuani, gli avrebbero sostituito nottetempo i paramenti sacri con abiti femminei; Vitaliano poi era uno di quelli che al mattino si vestono alla cieca, senza neanche accendere il lume, e così… in fondo sempre gonne sono, no? Devo dire che non è così implausibile. Meno di un vescovo col fetish degli indumenti femminili? Non saprei.
 |
| Fieni pure a noi, Fitaliano: noi capiamo le extrafakantze tegli uomini ti fede. |
Mi sto inventando.
È estate, dai.
Ma insomma rivolevano tutti ardentemente Vitaliano, e Vitaliano… non tornò. Cioè, sì, ma appena per un’ospitata di una sera – più che sufficiente a far piovere e ad allontanare il morbo. Ma non si fermò, si vede che non si sentiva più a suo agio; e forse presagiva la fine. Si ritirò in eremitaggio presso due o tre cime diverse – c’è sempre un po’ di concorrenza – nei pressi di Caserta o forse più verso Avellino, dove il Monte Virgiliano fu ribattezzato, in suo onore, Montevergine. E dove poteva anche infilare un paio di mutandine di pizzo sotto il cilicio senza che nessuno avesse niente da dire.
In occasione della sua festa, gli abitanti di Capua si vestono tutti da donne comprese le donne, e poi si abbracciano e si baciano fino al mattutino e anche oltre. No.
Mi sto inventando.
Ma sarebbe divertente, insolito, e credo che gioverebbe anche al turismo, insomma io se fossi nella pro loco ci farei un pensiero. Vitaliano è patrono di tutti gli uomini molto sbadati o che fanno finta, e che si vestono al buio e certe volte arrivano a lavorare con delle mises che ma ti sei visto? Eh, no, scusa, ancora no…. Mado’ che vergogna… San Vitaliano proteggimi.
martedì 9 luglio 2019
Tradurre in cattività: il caso Neon Genesis Evangelion
Non è responsabilità di Gualtiero Cannarsi se, fino a qualche giorno fa, i personaggi di Neon dicevano cose come “È col tentare di abbatterlo in fretta che la cosa si è fatta dura”, o “L’autoespulsione è entrata in attività”. Non è responsabilità sua se i doppiatori sono stati costretti a recitare battute che non capivano. Se a Cannarsi è stata data sempre più fiducia, malgrado i problemi fossero evidenti (e il pubblico non mancasse di notarli), la responsabilità è di chi questa fiducia per tutto questo tempo l’ha concessa. Ora Cannarsi pagherà anche per loro, ma quel che è successo è che un sincero cultore della materia è stato lasciato solo, per anni, al tavolo di lavoro, da committenti la cui negligenza a un certo punto deve aver interpretato come un attestato di fiducia. Magari sarebbe bastato poco: un editore, un distributore, un collaboratore che in tutti questi anni gli stesse accanto, gli rileggesse a voce alta le frasi che scriveva, lo aiutasse a non allontanarsi dall’italiano parlato e scritto. Qualcuno che smorzasse sul nascere certe velleità ermeneutiche che sono il tipico mostro che nasce dal sonno breve e agitato dei traduttori quando la scadenza comincia a essere troppo vicina (e la scadenza è sempre troppo vicina). Cannarsi invece è stato lasciato solo, e ha fatto quel che facciamo tutti quando siamo soli: ha iniziato a parlare con sé stesso, in una lingua tutta sua.
Tradurre è molto difficile. Bisogna avere due lingue in testa, e non è detto che nella nostra ci stiano davvero. Nelle orecchie, soprattutto, perché a volte è come ascoltare due musiche contemporaneamente. Magari non è impossibile, ma senz’altro non è una passeggiata, e il traduttore non fa altro tutto il giorno. Eppure ci basta leggere due o tre pagine in un’altra lingua, o anche solo ascoltare due o tre episodi in versione sottotitolata, per ritrovarci già in bocca qualche espressione che in italiano non esiste, qualche calco che un buon traduttore dovrebbe sempre saper aggirare, con leggerezza, mentre saltabecca da una lingua all’altra. Questo dovrebbe fare il traduttore ideale.
Quello reale il più delle volte sbanda, incespica, cade, e pur di rispettare una scadenza finisce per consegnare un ibrido italo-qualcosa che un editor (o più d’uno) faticosamente convertiranno in italiano. Non sempre riuscendoci, come chiunque può verificare aprendo un libro qualsiasi. Il traduttore è un traditore, dicevano, ma temo non renda l’idea. Un maledetto assassino, ecco cos’è un traduttore: anzi una spia, inviata a uccidere un testo che a volte conosce molto bene, al quale magari è affettivamente legato: proprio per questo si rende quasi sempre necessaria l’assistenza di professionisti in grado di mettere da parte gli affetti, ammesso che ne abbiano mai avuti: gente con la mano ferma quando c’è da impugnare il bisturi, la sega e gli altri attrezzi. Tradurre è un lavoro sporco, è la fine dell’innocenza: devi interiorizzare il concetto per cui il tuo rispetto per l’opera va subordinato al rispetto per un lettore italiano distratto che si stanca alla prima frase non scorrevole. Non lo accetti? Allora hai bisogno che qualcuno molto vicino a te non smetta di ricordartelo, a ogni capitolo, ogni pagina, ogni capoverso. Se Cannarsi non ha mai avuto qualcuno tanto vicino, non è colpa sua.
È una vittima designata, in un certo senso. L’uomo giusto nel momento sbagliato... (Continua su TheVision).
Per qualche anno Cannarsi si è ritrovato confinato in una confortevole nicchia di mercato: un limpido acquario lontano dall’oceano, dove le sue mostruosità erano ritenute inoffensive – forse persino decorative. I film dello studio Ghibli, in Italia, sono un prodotto per appassionati. Il fatto che per molti appassionati il doppiaggio sia un errore a prescindere ha fatto sì che alcune critiche siano passate inosservate agli addetti ai lavori. Ma il sospetto è che alcuni di questi addetti abbiano lasciato Cannarsi libero di fare scempio di lessico e sintassi perché il risultato sembrava aggiungere qualcosa alla versione italiana di quei film: un senso di straniamento, di esotismo che li proteggeva dalle critiche, rassicurando i fan sul fatto di trovarsi davanti a vere opere d’arte dai contenuti preziosi (e a volte enigmatici) e non a banali cartoni-animati-giapponesi per bambini. Un classico equivoco interculturale: i film di Miyazaki in effetti sono cartoni animati, e non hanno alcun bisogno di un registro aulico o pretenzioso per imporsi allo stesso pubblico trasversale che in Occidente si gode i film della Disney. Ma in Italia li si è proposti a un pubblico diverso, più adulto, che andava in un qualche modo confortato sul contenuto artistico dell’opera (quella che Walter Benjamin chiamava aura). Un pubblico del genere non poteva accontentarsi di pagare il biglietto per vedere belle favole: doveva anche avere la sensazione di immergersi in una cultura diversa.
In questo senso Cannarsi era l’uomo giusto. Quel che ha fatto ai film di Miyazaki ricorda in qualche modo l’operazione condotta sui testi omerici da una delle traduttrici italiane più celebrate del secolo scorso, Rosa Calzecchi Onesti. L’aedo omerico si rivolgeva a un pubblico eterogeneo di contadini, guerrieri, casalinghe, bambini: Rosa Calzecchi Onesti pensava essenzialmente ai laureandi in lettere che pur non avendo il tempo di leggere Omero in lingua originale, dovevano conservare l’illusione di esserne capaci. Da cui l’idea di riprodurre in italiano soluzioni sintattiche che l’italiano non consente, che rendono il testo più faticoso ma più ‘autentico’ per l’ex liceale che conservi qualche vaga nozione di grammatica greca. L'Omero calzecchizzato ha perso la sua universalità (non lo puoi più leggere ai bambini), ma ha acquisito l’aura necessaria per apparire un prodotto colto, adatto a un preciso segmento del mercato. Qualcosa di simile Cannarsi ha fatto con Miyazaki. Non c’era una semplice riga di dialogo che non riuscisse a complicare e a rendere esotica, straniante, sempre all’inseguimento di una fantomatica fedeltà “all’opera” che non si accorgeva di tradire. Il risultato è uno strano ibrido che senza suonare né italiano né particolarmente giapponese, ci fa capire che quello che vediamo non è il solito prodotto audiovisivo, ma qualcosa di più profondo che richiede uno sforzo supplementare. Qualcuno se ne lamentava, ma i puristi comunque preferivano i sottotitoli, e forse tutto sarebbe continuato così ancora a lungo, se a un certo punto Netflix non avesse ripreso la pratica di Neon Genesis Evangelion.
Anche qui c’è un equivoco, o forse più d’uno. NGE in Giappone è uno degli anime più popolari di tutti i tempi, mentre in Italia è rimasto un prodotto di nicchia, poco conosciuto al di fuori del bacino degli appassionati. Un bacino di dimensioni comunque rilevanti, ma tant’è; in Italia gli unici mecha a essere già entrati nell’immaginario collettivo sono quelli degli anni della tv dei ragazzi e delle prime emittenti private: Goldrake, Mazinga, eccetera. Quando finalmente il Corriere si è accorto del caso Cannarsi, ha ritenuto necessario spiegare ai propri lettori che Neon Genesis è una “nuova serie che si ispira a Goldrake” (per il lettore medio del Corriere tutto quello che è successo dopo il 1994 è “nuovo”). Segregati a lungo in una nicchia, i fan italiani dell’anime di Hideaki Anno hanno avuto tutto il tempo e l’agio per radicalizzarsi e sviluppare la convinzione che NGE sia molto più di un cartone di robottoni: un’opera profonda e complessa, intrisa di riferimenti culturali da decifrare con cautela. Il fatto che i personaggi non parlino tutto sommato una lingua molto diversa da quella degli altri anime a base di robottoni rischiava, anche stavolta, di danneggiare l’aura del capolavoro. Si veda l’estenuante dibattito sulla opportunità di tradurre shito come angelo o come apostolo, dando per scontato che Anno si ponesse davvero il problema della precisione nei rimandi biblici, e non stesse semplicemente pescando riferimenti colti un po’ a caso, confondendo Nuovo e Vecchio Testamento così come un autore italiano confonde serenamente Buddha e Budai. Un dibattito del genere è esattamente il mangime adatto per un pesce come Cannarsi, che può dimostrare il suo acume di filologo e rassicurare il pubblico adulto italiano sulla profondità di NGE: non il solito anime di robottoni, ma un’opera d’arte, dunque degna di un linguaggio aulico e accessibile solo agli iniziati.
E però Netflix non è la Lucky Red: il bacino di utenza è ormai molto più vasto e in particolare Netflix Italia in un primo momento potrebbe avere sottostimato la popolarità di NGE. Dal suo confortevole acquario, Cannarsi si è ritrovato sbalzato nell’oceano da un momento all’altro, senza avere gli strumenti per accorgersene. Ma ancora: com’è stato possibile che nessuno gli abbia impedito di consegnare ai doppiatori un testo che conteneva espressioni come “senza nessuna recalcitranza” o “hanno già completato di prendere rifugio”? Cannarsi scrive strano, ormai è il suo mestiere, anche se non è sempre consapevole. È abbastanza inutile pretendere che si renda conto di quel che ha fatto o che addirittura chieda scusa. Lui ha fatto esattamente quello che fa in questi casi, senza reagire alle critiche, anzi senza nemmeno capirle. Chi però in tutti questi anni lo ha lasciato lavorare indisturbato, qualche domanda dovrebbe porsela.
È una vittima designata, in un certo senso. L’uomo giusto nel momento sbagliato... (Continua su TheVision).
Per qualche anno Cannarsi si è ritrovato confinato in una confortevole nicchia di mercato: un limpido acquario lontano dall’oceano, dove le sue mostruosità erano ritenute inoffensive – forse persino decorative. I film dello studio Ghibli, in Italia, sono un prodotto per appassionati. Il fatto che per molti appassionati il doppiaggio sia un errore a prescindere ha fatto sì che alcune critiche siano passate inosservate agli addetti ai lavori. Ma il sospetto è che alcuni di questi addetti abbiano lasciato Cannarsi libero di fare scempio di lessico e sintassi perché il risultato sembrava aggiungere qualcosa alla versione italiana di quei film: un senso di straniamento, di esotismo che li proteggeva dalle critiche, rassicurando i fan sul fatto di trovarsi davanti a vere opere d’arte dai contenuti preziosi (e a volte enigmatici) e non a banali cartoni-animati-giapponesi per bambini. Un classico equivoco interculturale: i film di Miyazaki in effetti sono cartoni animati, e non hanno alcun bisogno di un registro aulico o pretenzioso per imporsi allo stesso pubblico trasversale che in Occidente si gode i film della Disney. Ma in Italia li si è proposti a un pubblico diverso, più adulto, che andava in un qualche modo confortato sul contenuto artistico dell’opera (quella che Walter Benjamin chiamava aura). Un pubblico del genere non poteva accontentarsi di pagare il biglietto per vedere belle favole: doveva anche avere la sensazione di immergersi in una cultura diversa.
In questo senso Cannarsi era l’uomo giusto. Quel che ha fatto ai film di Miyazaki ricorda in qualche modo l’operazione condotta sui testi omerici da una delle traduttrici italiane più celebrate del secolo scorso, Rosa Calzecchi Onesti. L’aedo omerico si rivolgeva a un pubblico eterogeneo di contadini, guerrieri, casalinghe, bambini: Rosa Calzecchi Onesti pensava essenzialmente ai laureandi in lettere che pur non avendo il tempo di leggere Omero in lingua originale, dovevano conservare l’illusione di esserne capaci. Da cui l’idea di riprodurre in italiano soluzioni sintattiche che l’italiano non consente, che rendono il testo più faticoso ma più ‘autentico’ per l’ex liceale che conservi qualche vaga nozione di grammatica greca. L'Omero calzecchizzato ha perso la sua universalità (non lo puoi più leggere ai bambini), ma ha acquisito l’aura necessaria per apparire un prodotto colto, adatto a un preciso segmento del mercato. Qualcosa di simile Cannarsi ha fatto con Miyazaki. Non c’era una semplice riga di dialogo che non riuscisse a complicare e a rendere esotica, straniante, sempre all’inseguimento di una fantomatica fedeltà “all’opera” che non si accorgeva di tradire. Il risultato è uno strano ibrido che senza suonare né italiano né particolarmente giapponese, ci fa capire che quello che vediamo non è il solito prodotto audiovisivo, ma qualcosa di più profondo che richiede uno sforzo supplementare. Qualcuno se ne lamentava, ma i puristi comunque preferivano i sottotitoli, e forse tutto sarebbe continuato così ancora a lungo, se a un certo punto Netflix non avesse ripreso la pratica di Neon Genesis Evangelion.
Anche qui c’è un equivoco, o forse più d’uno. NGE in Giappone è uno degli anime più popolari di tutti i tempi, mentre in Italia è rimasto un prodotto di nicchia, poco conosciuto al di fuori del bacino degli appassionati. Un bacino di dimensioni comunque rilevanti, ma tant’è; in Italia gli unici mecha a essere già entrati nell’immaginario collettivo sono quelli degli anni della tv dei ragazzi e delle prime emittenti private: Goldrake, Mazinga, eccetera. Quando finalmente il Corriere si è accorto del caso Cannarsi, ha ritenuto necessario spiegare ai propri lettori che Neon Genesis è una “nuova serie che si ispira a Goldrake” (per il lettore medio del Corriere tutto quello che è successo dopo il 1994 è “nuovo”). Segregati a lungo in una nicchia, i fan italiani dell’anime di Hideaki Anno hanno avuto tutto il tempo e l’agio per radicalizzarsi e sviluppare la convinzione che NGE sia molto più di un cartone di robottoni: un’opera profonda e complessa, intrisa di riferimenti culturali da decifrare con cautela. Il fatto che i personaggi non parlino tutto sommato una lingua molto diversa da quella degli altri anime a base di robottoni rischiava, anche stavolta, di danneggiare l’aura del capolavoro. Si veda l’estenuante dibattito sulla opportunità di tradurre shito come angelo o come apostolo, dando per scontato che Anno si ponesse davvero il problema della precisione nei rimandi biblici, e non stesse semplicemente pescando riferimenti colti un po’ a caso, confondendo Nuovo e Vecchio Testamento così come un autore italiano confonde serenamente Buddha e Budai. Un dibattito del genere è esattamente il mangime adatto per un pesce come Cannarsi, che può dimostrare il suo acume di filologo e rassicurare il pubblico adulto italiano sulla profondità di NGE: non il solito anime di robottoni, ma un’opera d’arte, dunque degna di un linguaggio aulico e accessibile solo agli iniziati.
E però Netflix non è la Lucky Red: il bacino di utenza è ormai molto più vasto e in particolare Netflix Italia in un primo momento potrebbe avere sottostimato la popolarità di NGE. Dal suo confortevole acquario, Cannarsi si è ritrovato sbalzato nell’oceano da un momento all’altro, senza avere gli strumenti per accorgersene. Ma ancora: com’è stato possibile che nessuno gli abbia impedito di consegnare ai doppiatori un testo che conteneva espressioni come “senza nessuna recalcitranza” o “hanno già completato di prendere rifugio”? Cannarsi scrive strano, ormai è il suo mestiere, anche se non è sempre consapevole. È abbastanza inutile pretendere che si renda conto di quel che ha fatto o che addirittura chieda scusa. Lui ha fatto esattamente quello che fa in questi casi, senza reagire alle critiche, anzi senza nemmeno capirle. Chi però in tutti questi anni lo ha lasciato lavorare indisturbato, qualche domanda dovrebbe porsela.
venerdì 5 luglio 2019
Maria12 perdona tutti
6 luglio - Santa Maria Goretti (1890-1902)
[2012]. La modernità è una crosta sottile, ha scritto qualcuno, in cui vivono solo alcuni di noi, e solo in alcuni momenti del giorno; altre ere, anche arcaiche, sono a portata di mano, letteralmente: afferri il telecomando, accendi la tv al pomeriggio, e non sei più nella modernità. Sei da qualche altra parte, molto prima o molto dopo, comunque altrove. Vedi cose che in altre ore del giorno non capiresti: ad esempio, le file per entrare ai processi. Anche d'estate, col caldo che fa, c'è gente che a certi processi vuole proprio assistere, e alla sbarra di solito non c'è lo speculatore che si è giocato i loro risparmi coi bond tossici; più spesso si tratta di un tizio che forse ha ammazzato qualcuno di cui non sono nemmeno parenti. Ma in quel momento del pomeriggio – sarà che hai caldo anche tu – sei in un'altra era e capisci che il concetto di parentela è relativo, chi è mia madre? chi è mio parente? Se i parenti sono le persone che vediamo tutti i giorni, ormai Sarah Scazzi è nostra cugina.
Possibile persino che ce la sogniamo di notte. Prima o poi qualcuno verrà a riportare un miracolo commesso da Yara Gambirasio, una grazia ricevuta da Ylenia Carrisi. Non credo che diventeranno sante: il calendario della Chiesa cattolica e quello della cronaca nera sono trasmessi ormai su due frequenze diverse. Però su quelle frequenze si trasmettono cose non dissimili, e forse all'inizio la frequenza era una soltanto. Poco prima del bivio, dello switch, c'è Maria Goretti: l'ultima santa antica, la prima protagonista moderna di un fatto di cronaca nera. Le sue eredi non sono più protagoniste di lunghe cause di canonizzazione; però i fiori, e gli altarini, dopo pochi giorni crescono già, abbarbicandosi ai cancelli delle case, spontaneamente. Dopo un po' arrivano anche i primi biglietti, i primi rudimentali ex voto. La modernità è una crosta sottile: se scavi un po' ti accorgi che sotto c'è ancora un Seicento vivo e pulsante che se la cava benissimo. Non teme la tecnologia, anzi: è cablato, ha le antenne, le parabole, tutto quello che gli serve a produrre e vendere devozione. Evidentemente c'è chi compra.
Di Maria Goretti si sa tutto e niente, nel senso che quel tutto più volte scandagliato da agiografi e giornalisti è comunque poca cosa: è nata; è vissuta in un contesto di miseria profonda, in questo contesto ha resistito tre volte alle avances di un uomo (oggi lo chiameremmo ragazzino) che viveva nella sua famiglia allargata; la terza volta è stata trafitta con un punteruolo; è morta soffrendo orribilmente e perdonando il suo assassino, anzi, perdonando tutti. Siccome la storia era tutta lì, la si poteva gonfiare di ideologia come un palloncino. Maria poteva diventare il simbolo della purezza cristiana, la sua storia si prestava a racconti imbastiti sulla stessa trama delle antiche leggende di santi: uomo cattivo, vergine pura, punteruolo, perdono, resurrezione. Fin troppo facile (eppure il processo di beatificazione andò per le lunghe). Al punto che il palloncino a un certo punto qualcuno lo sgonfiò e lo rivoltò dall'altra parte, e Maria Goretti diventò il simbolo di come la Chiesa opprimeva le donne, attraverso la diffusione di figure sottomesse e sessuofobe come la bambinella illetterata. È il palloncino che abbiamo visto più volte sventolare a sinistra, ma non è sempre stato così: fino agli anni Cinquanta la Goretti poteva ancora passare come una figura protofemminista. Sì, la bambina che difende il suo corpo dalla prepotenza dell'uomo fu persino raccomandata da Togliatti come modello alle ragazze comuniste. Secondo un'altra fonte fu un giovane Enrico Berlinguer a proporla, insieme a un altro recentissimo prodotto mitologico, la partigiana sovietica Zoya Kosmodeminskaja: la lotta contro il nazismo e contro la prepotenza maschile erano evidentemente da intendersi sullo stesso piano. [D'altro canto anche oggi non serve alcuno sforzo per includerla tra le martiri del patriarcato femminicida].
Negli anni Ottanta, in un momento di relativa bonaccia ideologica, un appena trentenne Giordano Bruno Guerri sceglie di compiere seriamente quello che in questo blog si fa per burla: irrompe nella stanza dei palloncini, prende quello già un po’ ammosciato della Virtù Eroica di Maria Goretti… e lo fa esplodere, bang! spaventando chi sonnecchiava nei paraggi. Il suo libro, Povera santa povero assassino, fa il botto: è una ricostruzione storica affidabile, vende bene, viene respinto dal Vaticano come blasfemo e sacrilego, ma costringe la Congregazione per le Cause dei Santi a convocare una commissione, che risponderà ribadendo le tesi del processo di canonizzazione: la Virtù Eroica di Maria Goretti è una Virtù Eroica, punto.
Guerri era di un altro parere. Nel giochino scemo destra-sinistra, G. B. Guerri non può che andare dalla parte di chi ha scritto tante cose su Mussolini e sul Ventennio, tiene una rubrica sul Giornale, ha organizzato celebrazioni per il centenario del futurismo, dirige il museo del Vittoriale. Però rileggere un suo libro degli anni Ottanta ti fa lo stesso effetto di guardare le prime vignette di Forattini degli anni Settanta: dalla distanza sembrano tutti di sinistra estrema. Probabilmente è vero il contrario: siamo noi che ci siamo spostati dall'altra parte, in moto rettilineo uniforme, tanto che a un certo punto Montanelli è diventato un compagno, semplicemente perché restava fermo mentre noi ci muovevamo. A rileggerla oggi, l’anti-agiografia di Guerri sembra costruita su un solido impianto marxista: prima di essere vittima del suo assassino, Maria Goretti è insieme al suo assassino vittima della miseria, del contesto socio-economico che la produce. La prima metà del libro è tutta appunto concentrata sul contesto, e fa spavento: Guerri documenta una povertà dickensiana, una barbarie alle porte di Roma, in una palude in cui il fatto di sangue è l’esito logico di una catena di circostanze inesorabilmente determinate: il vero responsabile, lo si legge più volte tra le righe, è il padrone che affama la santa contadinella e il contadino allupato. Quanto alla Chiesa, se a un certo punto riscopre la martire è ad uso propaganda: per Guerri è cruciale che, dopo tanti ritardi, il processo si sblocchi durante l’occupazione angloamericana, nel momento in cui la virtù delle fanciulle di Roma e Napoli veniva facilmente scambiata al mercato nero. Bisognava trovare un esempio di eroica resistenza al mercimonio della carne, e Maria Goretti era lì a immediata disposizione.
Quando finalmente si tratta di parlare di Maria come persona, Guerri non nasconde di aver poco da dire: Maria non ha identità, non può averla: non ha studiato, non sa leggere, non aveva le facoltà intellettive necessarie a comprendere i rudimenti della sua stessa religione: sarebbe morta ubbidendo a un Dio che non capiva. Togliatti, lo abbiamo visto, non sarebbe stato d’accordo: Dio o non Dio, Maria non voleva acconsentire a una prepotenza, e questo significa che aveva una coscienza, un coraggio da additare ai giovani. Ma ce lo ebbe davvero, tutto questo coraggio? Scartabellando tra gli atti del processo, Guerri scopre che di fronte al punteruolo Maria aveva esclamato Sì, sì, sì. Quel triplo sì, certificato dal suo assassino (ormai pentito, quarant’anni dopo il fattaccio) aveva creato non pochi problemi ai cardinali durante il processo di beatificazione. Avevano cercato di girarlo in vari modi: “sì” poteva essere considerato la ratifica della frase precedente, “vai all’inferno”? O magari Maria stava acconsentendo a essere accoltellata? Oppure (ci fu chi lo propose) non era proprio un “sì”, magari uno strillo isterico, un “hi hi hi”? Il grido tipico di chi viene minacciato di violenza con un punteruolo…
A distanza di trent’anni la ricostruzione di Guerri sembra ancora solida: eppure c’è qualcosa nel libro che lo fa sembrare in un qualche modo datato, espressione di un periodo felice in cui si potevano ancora scoppiare palloncini per il gusto di farlo. All’inizio pensavo che fosse un problema di scarsa empatia con la vittima, ma non è così: Guerri prova sincera pietas per la “povera santa” (ma anche per il “povero assassino”); il che non gli impedisce di indagare sulle frustrazioni sessuali del secondo e su uno dei pochi misteri della prima: perché faceva la Comunione così poco spesso? (Risposta: perché fisicamente non avrebbe retto il digiuno eucaristico). A mancare è piuttosto un certo tipo di impostazione che negli ultimi trent’anni è diventata lo standard, quando si parla di vicende di questo tipo. Per Guerri i motivi che portano Maria sul calendario sono complesse circostanze storiche, sociali, politiche, e anche diversi colpi di fortuna (fortuna per i parenti, e persino per l’assassino: smisero tutti di far la fame). Oggi, se una Sarah o una Yara diventano improvvisamente famose, noi non ci chiediamo il perché. La fama si spiega da sola, è autoevidente: una persona diventa famosa perché tutti ne parlano, e tutti ne parlano perché è famosa. Se in un primo momento ancora ci sforziamo di imputare la morbosità dei media, appena sorgono i primi altarini ci arrendiamo: c’è un inconscio collettivo da qualche parte, e i media non fanno che sondarlo; ogni tanto invece è lui che sbuca sotto la crosta sottile della modernità, e si mostra per quel che è: un beghino del Seicento, tale e quale. Ma non andò così anche con Maria Goretti?
Secondo Guerri no, non ci furono altarini né una particolare devozione popolare, prima della beatificazione. La notizia di cronaca anzi rischiava di non essere nemmeno pubblicata sui quotidiani clericali, che la ripescarono in chiave polemica (qualche giorno prima erano morti due amanti suicidi, e qualche quotidiano ne aveva approfittato per lamentare il mancato diritto al divorzio). Per molti anni gli unici miracoli, le uniche apparizioni, Maria le fece ai suoi famigliari. Insomma tutto il carrozzone della piccola Santa sarebbe stato imposto dall’alto: solo quando dall’alto arrivarono le prime agiografie, i primi santini, il popolo rispose dichiarando i primi miracoli, le prime grazie ricevute. Magari è andata così davvero. Ma gli altarini che nascono spontanei alle cancellate delle giovani protagoniste di fatti di cronaca mi fanno pensare che potrebbe essere andata diversamente: che un culto di Maria Goretti, sotterraneo, popolare, potrebbe avere tenuto viva la memoria della bambina fino all’inizio della causa di beatificazione; in seguito gli stessi alfieri della causa avrebbero avuto interesse a cancellare questo tipo di devozione dal retrogusto pagano, che potevano creare difficoltà nel dibattimento.
Alla fine sto gonfiando anch’io per quel che posso il mio palloncino: secondo me le religioni esistono prima delle Chiese, che sono un tentativo più o meno goffo, più o meno elegante di dare un’aria strutturata, consequenziale, a qualcosa che nasce già spontaneamente. Per pensarla così mi basta accendere la tv al pomeriggio, c’è la Vita in Diretta e mi sembra una cerimonia. Parlano di qualche bambina scomparsa, e all’improvviso sembra scomparsa anche per me. Cosa voleva dirmi? Quale mio peccato sta espiando? Non è chiaro; Mara Venier fa il possibile per spiegarmi, ma forse certe verità sono accessibili solo a un ristretto cerchio di iniziati.
 |
| Uno dei due ritratti autorizzati dalla madre (tra loro non si somigliano). |
Possibile persino che ce la sogniamo di notte. Prima o poi qualcuno verrà a riportare un miracolo commesso da Yara Gambirasio, una grazia ricevuta da Ylenia Carrisi. Non credo che diventeranno sante: il calendario della Chiesa cattolica e quello della cronaca nera sono trasmessi ormai su due frequenze diverse. Però su quelle frequenze si trasmettono cose non dissimili, e forse all'inizio la frequenza era una soltanto. Poco prima del bivio, dello switch, c'è Maria Goretti: l'ultima santa antica, la prima protagonista moderna di un fatto di cronaca nera. Le sue eredi non sono più protagoniste di lunghe cause di canonizzazione; però i fiori, e gli altarini, dopo pochi giorni crescono già, abbarbicandosi ai cancelli delle case, spontaneamente. Dopo un po' arrivano anche i primi biglietti, i primi rudimentali ex voto. La modernità è una crosta sottile: se scavi un po' ti accorgi che sotto c'è ancora un Seicento vivo e pulsante che se la cava benissimo. Non teme la tecnologia, anzi: è cablato, ha le antenne, le parabole, tutto quello che gli serve a produrre e vendere devozione. Evidentemente c'è chi compra.
Di Maria Goretti si sa tutto e niente, nel senso che quel tutto più volte scandagliato da agiografi e giornalisti è comunque poca cosa: è nata; è vissuta in un contesto di miseria profonda, in questo contesto ha resistito tre volte alle avances di un uomo (oggi lo chiameremmo ragazzino) che viveva nella sua famiglia allargata; la terza volta è stata trafitta con un punteruolo; è morta soffrendo orribilmente e perdonando il suo assassino, anzi, perdonando tutti. Siccome la storia era tutta lì, la si poteva gonfiare di ideologia come un palloncino. Maria poteva diventare il simbolo della purezza cristiana, la sua storia si prestava a racconti imbastiti sulla stessa trama delle antiche leggende di santi: uomo cattivo, vergine pura, punteruolo, perdono, resurrezione. Fin troppo facile (eppure il processo di beatificazione andò per le lunghe). Al punto che il palloncino a un certo punto qualcuno lo sgonfiò e lo rivoltò dall'altra parte, e Maria Goretti diventò il simbolo di come la Chiesa opprimeva le donne, attraverso la diffusione di figure sottomesse e sessuofobe come la bambinella illetterata. È il palloncino che abbiamo visto più volte sventolare a sinistra, ma non è sempre stato così: fino agli anni Cinquanta la Goretti poteva ancora passare come una figura protofemminista. Sì, la bambina che difende il suo corpo dalla prepotenza dell'uomo fu persino raccomandata da Togliatti come modello alle ragazze comuniste. Secondo un'altra fonte fu un giovane Enrico Berlinguer a proporla, insieme a un altro recentissimo prodotto mitologico, la partigiana sovietica Zoya Kosmodeminskaja: la lotta contro il nazismo e contro la prepotenza maschile erano evidentemente da intendersi sullo stesso piano. [D'altro canto anche oggi non serve alcuno sforzo per includerla tra le martiri del patriarcato femminicida].
Negli anni Ottanta, in un momento di relativa bonaccia ideologica, un appena trentenne Giordano Bruno Guerri sceglie di compiere seriamente quello che in questo blog si fa per burla: irrompe nella stanza dei palloncini, prende quello già un po’ ammosciato della Virtù Eroica di Maria Goretti… e lo fa esplodere, bang! spaventando chi sonnecchiava nei paraggi. Il suo libro, Povera santa povero assassino, fa il botto: è una ricostruzione storica affidabile, vende bene, viene respinto dal Vaticano come blasfemo e sacrilego, ma costringe la Congregazione per le Cause dei Santi a convocare una commissione, che risponderà ribadendo le tesi del processo di canonizzazione: la Virtù Eroica di Maria Goretti è una Virtù Eroica, punto.
Guerri era di un altro parere. Nel giochino scemo destra-sinistra, G. B. Guerri non può che andare dalla parte di chi ha scritto tante cose su Mussolini e sul Ventennio, tiene una rubrica sul Giornale, ha organizzato celebrazioni per il centenario del futurismo, dirige il museo del Vittoriale. Però rileggere un suo libro degli anni Ottanta ti fa lo stesso effetto di guardare le prime vignette di Forattini degli anni Settanta: dalla distanza sembrano tutti di sinistra estrema. Probabilmente è vero il contrario: siamo noi che ci siamo spostati dall'altra parte, in moto rettilineo uniforme, tanto che a un certo punto Montanelli è diventato un compagno, semplicemente perché restava fermo mentre noi ci muovevamo. A rileggerla oggi, l’anti-agiografia di Guerri sembra costruita su un solido impianto marxista: prima di essere vittima del suo assassino, Maria Goretti è insieme al suo assassino vittima della miseria, del contesto socio-economico che la produce. La prima metà del libro è tutta appunto concentrata sul contesto, e fa spavento: Guerri documenta una povertà dickensiana, una barbarie alle porte di Roma, in una palude in cui il fatto di sangue è l’esito logico di una catena di circostanze inesorabilmente determinate: il vero responsabile, lo si legge più volte tra le righe, è il padrone che affama la santa contadinella e il contadino allupato. Quanto alla Chiesa, se a un certo punto riscopre la martire è ad uso propaganda: per Guerri è cruciale che, dopo tanti ritardi, il processo si sblocchi durante l’occupazione angloamericana, nel momento in cui la virtù delle fanciulle di Roma e Napoli veniva facilmente scambiata al mercato nero. Bisognava trovare un esempio di eroica resistenza al mercimonio della carne, e Maria Goretti era lì a immediata disposizione.
 |
| "Dio non vuole. No! Alessandro, tu vai all'inferno. Sì. Sì. Sì". |
Secondo Guerri no, non ci furono altarini né una particolare devozione popolare, prima della beatificazione. La notizia di cronaca anzi rischiava di non essere nemmeno pubblicata sui quotidiani clericali, che la ripescarono in chiave polemica (qualche giorno prima erano morti due amanti suicidi, e qualche quotidiano ne aveva approfittato per lamentare il mancato diritto al divorzio). Per molti anni gli unici miracoli, le uniche apparizioni, Maria le fece ai suoi famigliari. Insomma tutto il carrozzone della piccola Santa sarebbe stato imposto dall’alto: solo quando dall’alto arrivarono le prime agiografie, i primi santini, il popolo rispose dichiarando i primi miracoli, le prime grazie ricevute. Magari è andata così davvero. Ma gli altarini che nascono spontanei alle cancellate delle giovani protagoniste di fatti di cronaca mi fanno pensare che potrebbe essere andata diversamente: che un culto di Maria Goretti, sotterraneo, popolare, potrebbe avere tenuto viva la memoria della bambina fino all’inizio della causa di beatificazione; in seguito gli stessi alfieri della causa avrebbero avuto interesse a cancellare questo tipo di devozione dal retrogusto pagano, che potevano creare difficoltà nel dibattimento.
Alla fine sto gonfiando anch’io per quel che posso il mio palloncino: secondo me le religioni esistono prima delle Chiese, che sono un tentativo più o meno goffo, più o meno elegante di dare un’aria strutturata, consequenziale, a qualcosa che nasce già spontaneamente. Per pensarla così mi basta accendere la tv al pomeriggio, c’è la Vita in Diretta e mi sembra una cerimonia. Parlano di qualche bambina scomparsa, e all’improvviso sembra scomparsa anche per me. Cosa voleva dirmi? Quale mio peccato sta espiando? Non è chiaro; Mara Venier fa il possibile per spiegarmi, ma forse certe verità sono accessibili solo a un ristretto cerchio di iniziati.






