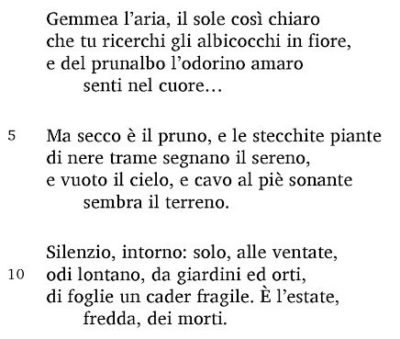25 novembre - Santa Caterina vergine e martire (III secolo)
[2012].
Caterina trae il suo nome da catha
, che vuol dire "universo", e ruina
, "rovina", come a significare "rovina universale". Con lei infatti ogni edificio del diavolo cadde in rovina... (Iacopo da Varazze, Legenda Aurea).
 |
Non mi fate scrivere chi è
l'autore, dai |
Caterina era una principessa che non dormiva mai mai mai, hai presente mai? come dire neanche adesso. Il re suo padre e la regina sua madre ci avevano provato in tutti i modi, con le fiabe di Grimm e di Andersen e di Calvino e di Vladimir Propp, e le canzoni dello zecchino d'oro d'argento e di bronzo i grandi successi di Mina e la Voce del Padrone, ma neanche il libro dei Salmi e la tavola degli elementi facevano addormentare la principessa Caterina, che invece di dormire imparava tutto. Infatti era anche intelligentissima, nonché molto intonata, e tutti potevano udirla alle tre del mattino cantare:
Avendo l'imperatore Massenzio convocato tutti, ricchi e poveri, ad Alessandria (EG) perché immolassero agli idoli pagani, proprio mentre stavano cominciando le celebrazioni sul più bello arrivò Caterina e disse dai, ma smettila, cosa sono tutti questi affari di ferro e legno e plastica non omologati CE? Non mi piacciono!, e sbing e sbleng e sbadabvong in dieci minuti aveva rotto tutti gli idoli del potente imperatore Massenzio, che disse: ma chi sei o giovane fanciulla impertinente?
"Sono Caterina", ella disse, "la patrona delle ruote dei carri-attrezzi e dei filatoi, perché giro tutta la notte e non mi fermo mai".
"Caterina, hai fatto un bel pasticcio. Ma adesso avrai sonno, almeno".
"Sonno io? No mai. Mi leggi un rotolo?"
"Che rotolo? Vuoi scherzare? Qui abbiamo solo papiri pregiati... ferma! stai strappando un Qumran originale!"
"Auff, le figure dove sono?"
"Senti Caterina, non ho tempo, sono il potente imperatore Massenzio, ho molti idoli da onorare, per cui adesso ci salutiamo, è stato un piacere, buonanotte e..."
"Che noia i tuoi idoli, lo sai che messi assieme non valgono nulla in confronto a mio papà?"
"E chi sarebbe tuo papà?"
"Mio papà è il più grande e il più bello di tutti, inoltre sa come va a finire la fiera dell'est".
"Ah-Ah, Caterina, tu scherzi, nessuno sa a come va a finire la fiera dell'est. Neanche Gugol".
"Lui ne sa più di Gugol, perché è mio papà".
"Dai Caterina piantala".
"No sul serio lui sa chi uccise il bue che bevve l'acqua che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane..."
Quando udì queste parole Massenzio rimase molto turbato, perché nessun suddito del suo impero conosceva la canzone fino al punto in cui il bue beveva l'acqua - anche il più anziano dei gugol di corte sapeva risalire fino all'acqua che spense il fuoco, ma il ruolo del bue in tutto ciò era stato ormai dimenticato da generazioni, insomma Caterina ne sapeva proprio a pacchi e Massenzio cominciò a tentennare, vuoi vedere che suo papà è davvero uno potente. Mah, boh, che si fa? Per prima cosa legàtela, disse Massenzio ai suoi collaboratori a tempo determinato.
"Sire, non si può, ella gira e non sta ferma un attimo".
"Dannata gioventù".
"Ci ha già fatto stramazzare tre cavalli a dondolo e uno gnu".
"Sfiancatela con l'altalena".
"Ha consumato la catena".
"Caterina ma insomma sei un totale disastro, cosa vuoi da me?"
"Devi accettare che mio papà è il più grande di tutti".
"Caterina ma insomma mettiti nei miei panni sono un imperatore malvagio che figura ci faccio?"
"Silenzio ora canterò la sigla della Pimpa originale".
"Ah ah Caterina piantala, nessuno si ricorda la sigla della Pimpa originale".
"
E la Pimpa corre e va / in campagna ed in città".
"Per gli dèi non è possibile! Tutte le videocassette della serie originale sono state distrutte nel rogo del quarantadiciannove! Com'è possibile che tu abbia accesso a codeste informazioni?"
"Me la canta sempre mio papà".
"Caterina senti non ho voglia di litigare, mi sembri una fanciulla piena di spirito e di sapienza, onora gli dei e farò di te la prima principessa del regno, anzi dell'impero, tutti si prostreranno a te e..."
"Non è che hai del panino?"
"Va bene, allora adesso facciamo così. Inviterò i cinquanta saggi più saggi dell'impero, verranno qui e discuteranno con te, ti confuteranno e ti surclasseranno in sapienza e a quel punto ti addormenterai, d'accordo?"
"Una zebra à pois, à pois, à pois".
"E non cambiare sempre argomento".
I cinquanta saggi all'inizio non volevano venire, millantavano impegni pregressi e dicevano: ma sul serio ci scomodi per una minorenne? Cioè per chi ci hai preso? Ti mandiamo uno stagista, ne abbiamo di molto bravi che non costano e non sporcano.
"No, no, dovete venire proprio voi. Vi prometto ricchi premi e un sontuoso coffibrek, ma addormentatela, addormentatela ve ne prego".
"Beh vabbe' se insisti veniamo, ma non piangere, dai, sei un imperatore crudele o cosa sei?"
"Non ce la faccio più! Non dormo da una settimana! Sul lavoro ho le allucinazioni! Mi trottola sempre da ogni parte del campo visivo!"
"Non te la devi prendere, son ragazzi".
"Ho una pila di papiri arretrati che non finisce più, al lavoro non so più che scusa inventarmi, vi prego fate qualcosa".
I saggi scossero le lunghe barbe e salirono in groppa agli stagisti. Il viaggio durò una settimana. Nel frattempo ad Alessandria ormai la prodigiosa Caterina era sulla bocca di tutti, per via che sapeva contare fino a dodici e distingueva le macchine rosse da quelle blu, e tutti lodavano la sua sapienza. Quando i saggi arrivarono, lei volle tirare le barbe a ciascuno di loro, trovandole tutte in ogni caso deludenti rispetto a quella di papà. Il colloquio verté su argomenti di filosofia, diritto naturale, e su quale fosse la precisa sequenza degli animali nel Pulcino Pio. Ben presto i saggi cominciarono a traballare, e quindi a stramazzare al suolo addormentati, uno alla volta. Dopo tre ore l'imperatore bussò ma nessuno gli apriva, così entrò da solo e vide Caterina seduta su un tappeto di vecchie barbe addormentate che cantava I Più Grandi Successi Del Quartetto Cetra.
"Svegliatevi!" urlò. "Con quello che mi costate di rimborso spese! Possibile che una giovane fanciulla tenga testa a tutti voi?"
"Sire non c'è niente da fare", dissero quelli. "Conosce le lingue degli uomini e degli animali da cortile, e i nomi dei sette nani".
"Di tutti i sette nani? Mi prendete in giro. Nessuno è mai riuscito a..."
"E riconosce ogni singolo barbapapà per nome colore e competenza. A malincuore dobbiamo ammettere che suo papà è veramente un tizio tosto".
Al sentire queste parole, Massenzio fu scosso da una terribile ira e ordinò che fossero tutti torturati con l'aspirazione nasale.
"NO! Ti preghiamo, crudele imperatore, scanna i nostri stagisti e nutricati delle loro frattaglie, ma l'aspirazione nasale no!"
Ma l'imperatore fu irremovibile. E poi, siccome i martiri sono un po' come le ciliegie, uno tira l'altro, decise già che c'era di ordinare uno strumento di tortura per la giovane Caterina, un meccanismo con molte ruote dentate. Ma Caterina, che ve lo dico a fare? Appena provarono a legarla si mise a girare, e girava così forte che la ruota dentata grippò, e l'ingranaggio saltò in testa al re, che ne riportò un bernoccolo con prognosi riservata per duemila anni.
E poi basta, Caterina non è mica stata martirizzata nel terzo secolo come dicono certi stupidi calendari, certe stolte leggende auree o argentee o bronzee. Nessuno poteva martirizzarla, Caterina era troppo veloce, e non potevano neanche aspettare che si addormentasse, perché Caterina non dormiva mai. E non dorme neanche adesso, se senti bene in fondo al corridoio senti che canta
Folle, folle banderuola
folle banderuola senza tempo
che giri come il sole e come il lampo
sul tetto rrrrrrosso del mio cuor
tirintirintin tì!
[Questo pezzo è stato pubblicato la prima volta
nel 2012].